EDITORIALE di Anna Armone
La riforma della scuola non potrà mai essere una vera riforma se non si riformano gli organi collegiali e lo stato giuridico dei docenti?
Non so a quale punto dell’attuazione della l. 107/2015 saremo quando il numero della rivista verrà pubblicato. Oggi, in piena estate navighiamo a vista nel mare del fare senza guida certa, senza coerenza normativa, senza visione.
In questi giorni di grande animosità per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, mi sono chiesta se c’è attinenza tra il fallimento dell’idea d’Europa così come è stata dipinta e pubblicizzata nel corso del tempo e le vicende, più piccole, ma non meno importanti, del sistema scolastico italiano.
Un elemento in comune l’ho trovato. L’idea che le riforme, le grandi riforme, debbano passare assolutamente attraverso modelli gestionali “del fare” mi pare sia presente nel modello europeo degli ultimi tempi. Anziché visioni dell’agire comune e conseguenti provvedimenti, l’unificazione delle azioni dei singoli Paesi passa attraverso centinaia, se non migliaia di regolazioni minute che spesso sembrano non avere senso. La legge comunitaria italiana di recepimento degli obblighi comunitari lascia perplessi per gran parte dei suoi contenuti che, nell’adempimento doveroso, vanno a regolare aspetti lontanissimi dalla vita dei cittadini europei.
Questo modello se rimane lontano dalla quotidiana riconoscibilità dei cittadini finisce per diventare un modello di gestione affaristica, nella quale lobby, interessi particolari forti, spinte populiste possono trovare spunti di strumentalizzazione. Ma non è l’Europa al centro delle mie riflessioni, essa è solo uno sfondo di ragionamento. Il sistema scolastico italiano e, in particolare, la l. 107, mi appare come un processo composito che parte da una visione della scuola fondata su antichi principi partecipativi (anzi li accentua) per arrivare a delineare un modello di Governance, una vera e propria gestione, basata su presupposti concettuali e teorici del tutto lontani dall’idea di “scuola”. I principi portati a fondamento della riforma, l’efficientamento del sistema scolastico che passa attraverso la redditività del lavoro degli insegnanti e della responsabilità dirigenziale, sembrano avulsi da qualsiasi considerazione di sistema. ... Purché si intervenga, purché si inizi, purché si smuova il sistema. Siamo sicuri che questo modello funzioni?
Se facciamo un giro negli altri Paesi del vecchio continente (non voglio escludere la Gran Bretagna) questa complessità che troviamo in Italia non esiste. Non è una questione di autonomia. L’autonomia, laddove esiste, afferisce alla missione istituzionale, non è sinonimo di autogestione, a meno che non si tratti di un soggetto collocato in una posizione ben delineata giuridicamente e collocata nel sistema. Pensiamo alla scuola paritaria, che fa parte del sistema pubblico, ma ha un modello autoconsistente.
Il sistema dell’istruzione è ancora oggi un sistema ministeriale, afferendo al Governo centrale la programmazione strategico politica del settore. Tale impostazione è coerente con la recente riforma costituzionale che ha coinvolto anche il Titolo V, l’art. 117 in particolare. L’evoluzione verso un modello di rinforzo gestionale dell’istruzione, da far gravare sul territorio e sulle scuole è stata bloccata dal rallentamento, fino al blocco finale, proprio del disegno costituzionale di riforma del Titolo V del 2001. In quel disegno la programmazione della politica scolastica avrebbe dovuto trovare una sua dimensione territoriale attraverso l’esercizio del potere legislativo concorrente delle regioni. È vero che solo due regioni hanno assolto tale compito, l’Emilia Romagna e la Lombardia, ma la responsabilità va ricercata anche nell’incompiutezza della riforma costituzionale. Presupposto e corollario all’esercizio della funzione legislativa concorrente delle regioni in materia di istruzione avrebbe dovuto essere il federalismo fiscale con il connesso passaggio delle funzioni e delle competenze. Bisogna ricordare che per anni lo Stato in conferenza unificata ha patteggiato modalità di realizzazione della piena attuazione della riforma del Titolo V in materia di istruzione nell’ambito del Masterplan. Parliamo di un lasso di tempo che va dal 2006 al 2012. Tutti i Ministri dell’Istruzione firmavano l’accordo in Conferenza unificata ma poi dell’accordo si perdevano le tracce. E così l’incapacità di cui sono oggi accusate le regioni e che ha portato all’ulteriore riforma del Titolo V si estende anche ad una materia per la quale non è facile stigmatizzare in modo assoluto comportamenti inadempienti.
Oggi, dunque, la riforma del sistema scolastico non può e non deve essere descritta in termini di doveroso cambiamento a fronte dell’immobilismo legislativo. Il “purché si riformi”, oggi, si scontra con un intervento riformatore dalle fondamenta d’argilla, assai pericoloso perché la debolezza della struttura riformatrice può innestare, come in parte sta già accadendo, da una parte una resistenza ideologica ad una regolazione di rapporti e prestazioni afferenti a zone, fino ad oggi franche, delle prestazioni degli operatori scolastici, dall’altra si può innestare un’assuefazione, passiva e arresa, ad una riforma che colpisce nel vuoto regolativo lasciando sul terreno una libertà professionale dei docenti mortificata (perché non regolata) e un nuovo, falso, potere dirigenziale.
Non funziona così un processo riformatore. Non può giustificarsi con il richiamo alla lunghezza dei tempi dell’approvazione parlamentare di una legge ordinaria, un intervento caotico e rattoppato. Ritorno, ancora, sul tema già più volte trattato dello stato giuridico dei docenti, con tutto ciò che ne consegue (declinazione chiara dei diritti e dei doveri, sviluppo di carriera) e della riforma degli organi collegiali di istituto.
Se andiamo a rileggere la legge “Bassanini” già nel 1997 il legislatore prevedeva e richiedeva la riforma degli organi collegiali e la definizione dello stato giuridico dei docenti.
Non può essere un decreto legislativo di riscrittura del Testo unico sulla scuola a cambiare la struttura organica della scuola, né definire la libertà di insegnamento in modo funzionale al disegno della l. 107/2015.
Il legislatore non può essere oppresso dalla fretta portata dalla conclusione della legislatura e partorire, di conseguenza, i rattoppi normativi necessari a dare una parvenza di legittimità e coerenza alla riforma. Se l’impianto dellal. 107 si ritiene debba costituire la visione della scuola dei prossimi anni, allora il Parlamento deve farsi carico di sistemare il quadro normativo di riferimento, partendo dalla riforma degli organi collegiali, anzi, da una pregiudiziale che oramai va affrontata: la scuola è un organo con personalità giuridica del MIUR o è un soggetto entificato autonomo? E in entrambi i casi bisogna decidere se i principi inderogabili di macro organizzazione e micro organizzazione descritti nel d.lgs. 165/2001 vanno o meno applicati alla scuola, perché se la scuola afferisce alla tipologia delle amministrazioni pubbliche previste dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, allora l’impianto decisionale deve rispettarne i principi inderogabili. Se, invece, la scuola, è parte del MIUR, quale organo con personalità giuridica, allor bisogna ripensare agli automatismi fino ad oggi adottati di ripercussione automatica della normativa generale della Pubblica amministrazione sulla scuola.
Non bastano i corollari previsti dalla l. 107 a sanare incoerenze, vuoti e contraddizioni con il quadro sistemico dell’impianto amministrativo e normativo; occorre ricomporre il quadro inserendo la scuola, una volta per tutte, in un quadro coerente e riconoscibile di attribuzioni, poteri e responsabilità. E bisogna iniziare dai docenti e dagli organi collegiali. La funzione dirigenziale è conseguenza e non motore di tali assetti.
Ed ora veniamo a questo numero della rivista. Iniziamo con un pezzo, di ampio respiro, quello di Giancarlo Sacchi. Si tratta di un approfondito excursus del sistema scolastico nei suoi rapporti con il territorio. L’autore spazia dalle politiche dell’infanzia alle politiche dell’istruzione, analizzando compiutamente modelli di Governance e processi decisionali. Viene altresì analizzata l’evoluzione del processo autonomistico delle scuole e la fase regressiva rilevata nel corso del tempo. Un altro versante in cui le politiche territoriali hanno assunto una particolare importanza riguarda quello che oggi si dice“apprendimento permanente”, che affonda le sue radici nella “scuola popolare” contro l’analfabetismo, che ha preso le mosse nell’ultimo dopoguerra. Prosegue, l’autore, con l’analisi approfondita dell’istruzione e formazione professionale fino ad arrivare alla prospettazione della riforma costituzionale che sarà sottoposta a referendum popolare.
Maria Grazia Accorsiaffronta il tema dei curricoli verticali unitari integrati, ripercorrendo la normativa sin dal d.p.r. 275/1990 che aveva previsto la definizione di appositi modelli di certificazione da parte del Ministero a valere per tutte le scuole. Nel corso degli anni la tematica è stata più volte ripresa da norme di settore e rinviata ad ulteriore normativa. L’autrice richiama le ricerche dell’Indire e dell’Invalsi e lo stato delle cose lo affidiamo alle sue stesse parole: “Nel balletto barocco delle norme, i passi ritornano insistentemente su alcuni punti chiave che saranno molto probabilmente quelli sui quali si eserciterà la disciplina: quale l’oggetto del giudizio (competenze - culturali, trasversali, ‘chiave’; conoscenze disciplinari; comportamento; ecc.)? quale il linguaggio (numeri o parole; livelli; scale ordinali)?; quale lo scopo (classificatorio e selettivo; formativo e orientativo; rendicontazione sociale); quali gli standard del ‘servizio’?”.
Renato Loieroanalizza la spesa per l’istruzione a margine dei documenti di bilancio. L’analisi dell’andamento della spesa fa riferimento anche ad analisi internazionali. Esaminando l’avvicinamento agli obiettivi nazionali della strategia Europa 2020 per quando concerne l’istruzione, emerge che l’Italia ha compiuto progressi verso la riduzione dell’abbandono scolastico e all’incremento del tasso di istruzione terziaria. Sono invece necessari ulteriori sforzi per quanto riguarda l’aumento del tasso di occupazione, gli investimenti in ricerca e sviluppo e la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale.
Anche le recenti indagini Istat-Bes del 2014 e del 2015 mostrano come il nostro sistema di istruzione, pur caratterizzandosi per un aumento del livello di istruzione e formazione della popolazione, non raggiunge la media dei paesi Ue-27. In particolare, come evidenziano in un recente studio, la quota di persone tra i 25 ed i 64 anni con almeno il diploma superiore è passata dal 56% della popolazione del 2011 al 58,2% nel 2013. Per quanto concerne l’abbandono scolastico, mentre tra il 2011 ed il 2013 si è registrata una diminuzione dal 18,2% nel 2011 al 17% nel 2013 della percentuale di giovani che escono prematuramente dal sistema di istruzione e formazione dopo aver concluso la secondaria di primo grado, la situazione italiana rimaneva ancora sensibilmente sopra il 17% degli allora 27 paesi Ue15.
Ivana Summaaffronta il tema della formazione del personale scolastico alla luce della l. 107/2015. Parte dall’excursus storico del regime giuridico della formazione per arrivare ad un’approfondita analisi organizzativa del fenomeno, offrendo un percorso logico di analisi, elaborazione ed implementazione del bisogno formativo. A supporto dell’iter ricostruito vengono richiamati i documenti di programmazione dell’istituzione scolastica, prospettando, in tal modo, una forte coerenza tra gli obiettivi da perseguire e il miglioramento ed arricchimento delle professionalità.
Vanna Monducci completa le riflessioni contenute nel numero 2/2016, nel quale ha illustrato le principali evidenze emerse dal Summit sulla professionalità docente che si è tenuto nel marzo scorso a Berlino. In questa seconda parte della trattazione sintetizza quanto si sta facendo, negli Stati che hanno partecipato al Summit, per qualificare la professionalità degli insegnanti ed avere una scuola più efficace ed equa in un contesto che sta cambiando sempre più rapidamente, e che deve affrontare grandi e impegnative sfide che mettono alla prova i sistemi scolastici anche più avanzati.
Francesca Rescignooffre una disamina approfondita del tema dell’insegnamento della religione cattolica, attraversando quasi due secoli di storia nei quali è venuto a delinearsi il modello educativo della materia. Dalla riforma Gentile alla regolazione concordataria, fino all’ultima modifica del Concordato con la Chiesa, emerge, oggi, finalmente una posizione laica dello Stato. “Se si continua a ritenere necessaria una prospettiva religiosa nella scuola, allora tale insegnamento deve indirizzarsi in maniera generale al ‘fatto religioso’, affrontando con metodologie laiche e neutrali la conoscenza dei fenomeni religiosi nelle loro varietà storiche ed attuali perché solo una scuola veramente laica, che rispetti tutte le fedi senza privilegiarne alcuna, realizza il principio di eguaglianza e contribuisce alla costruzione di una cittadinanza consapevole e democratica”.
Carmen Iuvonefa una prima analisi del disegno di legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta, dal Senato nella seduta del 16 gennaio 2016 e dalla Camera dei Deputati nella seduta del 12 aprile 2016. Dopo l’analisi critica dei contenuti della legge, Iuvone entra nella nuova regolazione della materia dell’istruzione, evidenziandone gli elementi di continuità e di discontinuità rispetto all’attuale assetto costituzionale.
Giuliana Costantini, nella rubrica di recensioni letterarie, illustra tre libri di autori italiani. Il primo libro è stato scritto da Giordano Meacci, Il cinghiale che uccise Liberty Valance. Si tratta di una storia allegorica, nella quale la figura del cinghiale che si muove tra gli uomini, richiama ad ognuno personaggi noi. è un romanzo insieme colto e piacevole che supera senza dubbio ogni interpretazione personale.
Il secondo libro è di Raffaella Romagnolo, La figlia sbagliata. È una storia tragica ambientata in una famiglia che scopre, nel momento drammatico, il bisogno di farsi domande.
Il terzo libro è di Simona Baldelli, La vita a rovescio, è una storia ambientata nel 1735, ma contemporanea, imperniata sulla doppia vita di una giovane donna che sconterà la sua identità sessuale.
La rassegna cinematografica curata da Vincenzo Palermo, in questo numero offre un approccio didattico ed educativo, frutto della sua recente esperienza come insegnante di lettere. Palermo ha utilizzato due film, Explorers [Id., USA 1985], regia: Joe Dante e Super 8 [Id., USA 2011], regia: J.J. Abrams accomunati da un elemento fondamentale per un fine pedagogico: la volontà di esprimere un insegnamento in chiusura d’opera, non di rado a carattere morale, che rende le pellicole due favole moderne a tutti gli effetti. L’esperimento didattico si è realizzato con l’apporto degli alunni, con dibattiti e riflessioni in classe sul tema e la promessa, da parte di alcuni ragazzini assai ispirati, di realizzare presto una sceneggiatura scritta da loro per un film di fantascienza. X





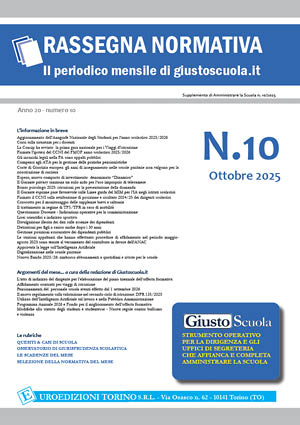
 Relatori: Le lezioni saranno tenute dalla D.ssa Antonietta Di Martino e Ing. Paolo Pieri autori del testo SALUTE e SICUREZZA NELLA SCUOLA Edito da Euroedizioni
Relatori: Le lezioni saranno tenute dalla D.ssa Antonietta Di Martino e Ing. Paolo Pieri autori del testo SALUTE e SICUREZZA NELLA SCUOLA Edito da Euroedizioni




.png)
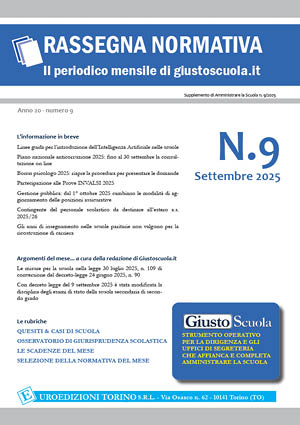
 La Casa Editrice EUROEDIZIONI propone un corso di formazione on line dal taglio pratico ed operativo destinato ai Direttori amministrativi anche di nuova nomina e agli Assistenti amministrativi facenti funzioni per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che il profilo gli assegna.
La Casa Editrice EUROEDIZIONI propone un corso di formazione on line dal taglio pratico ed operativo destinato ai Direttori amministrativi anche di nuova nomina e agli Assistenti amministrativi facenti funzioni per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che il profilo gli assegna.










 Con il nuovo numero di
Con il nuovo numero di 




.png)






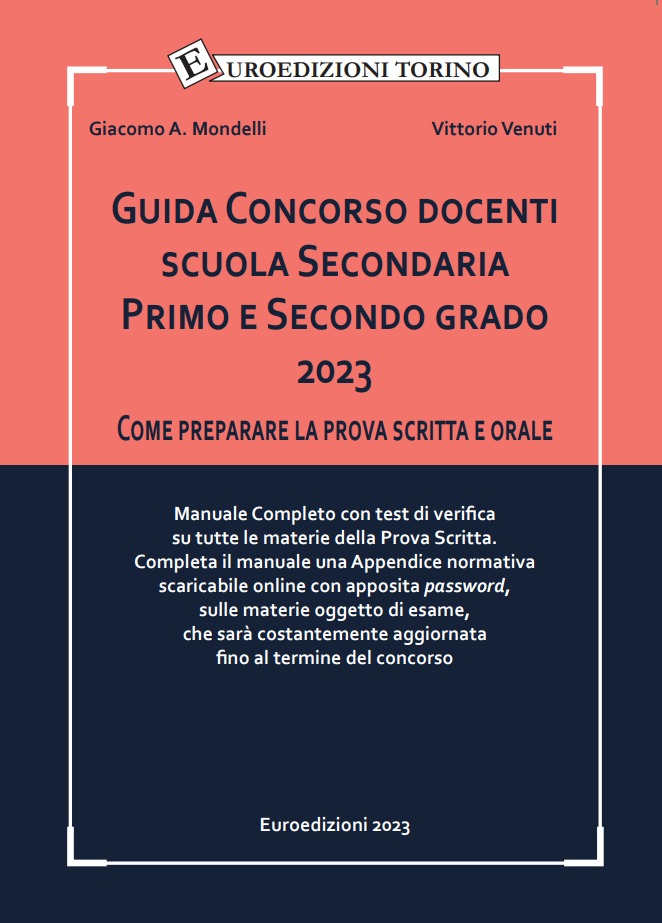
.jpg)






.jpeg)
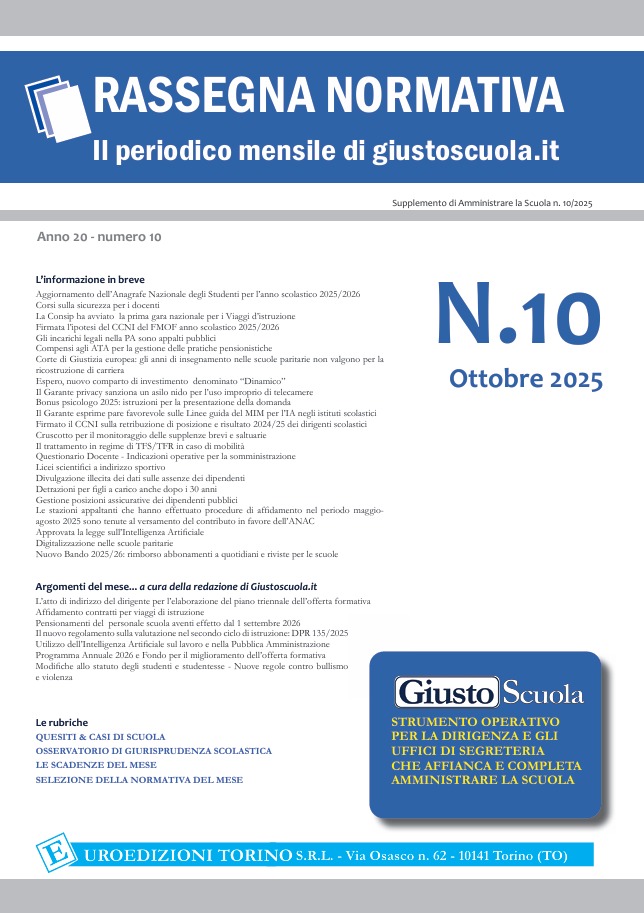
.png)





.jpeg)




