 Un atto di indirizzo fuori tempo e fuori tema
Un atto di indirizzo fuori tempo e fuori tema
Le riflessioni che seguono hanno lo scopo di inquadrare l’atto politico-istituzionale della Ministra Azzolina in un ipotetico circuito logico razionale, considerato che, come vedremo, si tratta esclusivamente di una ripetizione pedissequa degli obiettivi strategici già presenti nella legge di bilancio del Ministero dell’istruzione 2021.
La programmazione strategica costituisce il collegamento tra la fase di pianificazione/programmazione economico-finanziaria e la fase della gestione, attraverso un sistema di indicatori adeguati a ciascun obiettivo individuato.
La pianificazione strategica è, dunque, la traduzione degli orientamenti della politica in strumentazione, in modo da definire le direttive di medio-lungo periodo per l’organizzazione.
I documenti espressione delle fasi decisionali sopra descritte sono:
· il programma politico elettorale
· le linee programmatiche di mandato
· il bilancio dello stato (che media tra gli obiettivi dei singoli Ministri definiti nell’atto di indirizzo politico di ogni Ministro e le risorse disponibili)
· la direttiva annuale sull’azione amministrativa e la gestione che individuati gli obiettivi gestionali che dovranno essere declinati in piani operativi d’azione.
· il piano della performance
Centriamo l’attenzione sull’atto di indirizzo politico istituzionale che deve essere emanato prima dell’approvazione della legge di bilancio. L’atto indica le priorità politiche che il Ministero, tramite i propri Centri di Responsabilità Amministrativa, intende realizzare nel corso dell’anno successivo, in linea con il relativo bilancio di previsione e avviando così, al contempo, il processo di pianificazione strategica che avrà seguito nella Direttiva annuale e nel Piano della Performance, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 286/99 e dal decreto legislativo n. 150/09.In particolare, le direttrici portanti per la costruzione della programmazione strategica verranno indicati nel Piano della Performance triennale, contenente la Direttiva annuale, in coerenza con i contenuti della programmazione economico-finanziaria generale.
Gli esiti della discussione di bilancio si concretizzano nella Nota integrativa, prevista dall’art. 21, comma 11, lettera a) della legge di riforma contabile n. 196/2009 che completa e arricchisce le informazioni del Bilancio e costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero, in coerenza con il quadro di riferimento socioeconomico e istituzionale nel quale opera e con le priorità politiche assegnate, illustra i criteri di formulazione delle previsioni finanziarie in relazione ai programmi di spesa, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli.
La Nota integrativa si inserisce all'interno del più ampio processo di programmazione che prende avvio dalla definizione generale degli obiettivi di Governo e dalla loro declinazione nell'ambito delle singole Amministrazioni, passa attraverso la verifica di compatibilità delle previsioni iniziali di Bilancio con i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica, di competenza della Ragioneria Generale dello Stato, e si conclude, dopo l'approvazione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio, con l'elaborazione delle Direttive annuali emanate dai Ministri, contenute nel “ Piano delle performance” introdotto con decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.
Con le Note integrative al Bilancio di previsione - allegate al disegno di legge del Bilancio e aggiornate con legge di Bilancio - le amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai programmi di spesa ed i relativi indicatori di risultato in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione sui programmi di pertinenza (ai sensi dell’art. 21 comma 11, lett. a) della legge 196/2009) (RGS).
La Nota integrativa, prevista dalla legge di riforma della contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, è, dunque, un documento di ausilio alla programmazione dell’impiego delle risorse pubbliche.
Esso completa e arricchisce le informazioni relative al Bilancio e al Rendiconto generale dello Stato e rappresenta l’elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica, nonché con il ciclo della performance.
Per garantire l’integrazione tra il ciclo del bilancio, della programmazione strategica e della performance di cui al decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni, le amministrazioni si avvalgono di un quadro strategico di riferimento unico per la predisposizione dei relativi adempimenti.
Un ciclo coordinato prende avvio dall’individuazione delle finalità della spesa pubblica e delle priorità politiche coerenti con la programmazione finanziaria declinata nel Documento di economia e finanze per il successivo triennio.
Tali indicazioni, eventualmente rafforzate dagli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 286/1999 e da Atti di indirizzo dei singoli Ministeri, consentono di individuare gli obiettivi strategici (RGS).
L’iter decisionale della spesa si conclude con l’assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni tramite il bilancio per il perseguimento degli obiettivi strategici collegati alle priorità politiche e degli obiettivi strutturali dell’amministrazione.
Venendo all’atto del Ministro Azzolina riportiamo il seguente incipit: “Si riportano di seguito le priorità politiche sulla base delle quali il Ministero dell’istruzione definirà gli obiettivi strategici dell’Amministrazione e la consequenziale allocazione delle risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione della spesa per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023.
Coerentemente con le priorità definite nel presente Atto d’indirizzo politico-istituzionale, saranno individuati gli obiettivi strategici che i titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa del Ministero saranno chiamati a conseguire, con l’impiego delle dotazioni finanziarie e delle risorse umane e strumentali assegnate alle proprie strutture”.
Chi non ha chiara la sequenza decisionale della programmazione strategica pensa che i giochi siano ancora da definire. Al contrario, la spesa è già stata definita nello stato di previsione per l’anno 2021, ma non solo. Gli obiettivi riportati nell’atto del Ministro sono estrapolati, se non completamente riportati, dalla nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione. Corrispondono anche i titoli dei paragrafi. Tale atto dovrebbe afferire, come abbiamo visto nella prima parte, ad un momento preliminare alla redazione del bilancio e costituire la premessa per il successivo atto di indirizzo sull’azione amministrativa e la gestione. L’atto politico del Ministro avrebbe dovuto indicare, prima dell’approvazione della legge di bilancio, le priorità politiche che il Ministero, tramite i propri Centri di Responsabilità Amministrativa, intendeva realizzare nel corso dell’anno 2021, in linea con il relativo bilancio di previsione e avviando così, al contempo, il processo di pianificazione strategica che solo con la Direttiva annuale sull’azione amministrativa e la gestione si realizza (e che non è stata emanata nemmeno nello scorso anno. L’ultima direttiva annuale del Ministero dell’istruzione risale al 2019). Peraltro, la direttiva annuale fa oramai parte integrante del Piano della Performance, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/09. Coerentemente, nel vigente Piano della Performance del Ministero dell’istruzione si legge “è un documento programmatico che comprende: gli obiettivi strategici ed operativi dell'amministrazione contenuti nella Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione emanata dal Ministro; gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa e della performance individuale, contenuti nelle Direttive dei Capi Dipartimento e dei Direttori generali”.
Oltre alla dubbia tempistica dell’atto, è altresì il contenuto che non è proprio coerente con obiettivi strategici che si realizzano attraverso l’azione amministrativa e non legislativa. Si riporta uno stralcio dell’atto in discussione: “In considerazione della sempre più evidente complessità che connota la dirigenza scolastica, costantemente orientata a garantire il buon andamento e la correttezza dell’azione amministrativa ma anche chiamata a gestire in maniera competente le sfide che le nuove generazioni pongono quotidianamente alla scuola, in termini di scelte, offerta di qualità, opportunità formativa e orientamento, sarà necessario valutare la definizione, in seguito ai necessari passaggi legislativi e contrattuali, in spirito di ampia condivisione, per la prima volta, dell’area del cd. middle management, cui possano accedere, secondo modalità trasparenti, docenti capaci, per esperienza, professionalità e vocazione, di gestire attività complesse formalmente delegate, tra quelle di competenza del dirigente scolastico, anche al fine di determinare nuove e più compiute professionalità che possano successivamente concorrere al ruolo della dirigenza scolastica con un bagaglio di esperienza organizzativa e di sensibilità amministrativa maturato in tale nuova area professionale”.
Anche se encomiabile la volontà del Ministro di valorizzare e sbloccare la funzione docente fossilizzata oltre ogni limite, non si comprende tale previsione in un atto che, per essere positivi, si potrebbe definire manifesto politico, nel senso di dichiarazione che ripropone obiettivi già definiti nella nota integrativa al bilancio. L’intervento annunciato non ha natura politico-amministrativa, ma legislativa e possiamo solo attribuire il merito di aver evidenziato un’esigenza condivisa da più parti.
Lo stesso ragionamento va fatto per un altro passaggio dell’atto della Ministra“Nell’ottica della semplificazione del corpus normativo scolastico, che attualmente si caratterizza per complessità ed eccessiva stratificazione, è necessario procedere alla revisione del D. Lgs. 297/1994,razionalizzandone l’impianto e rendendolo coerente con le caratteristiche e l’attuale forma dell’amministrazione scolastica, così come è venuta delineandosi e trasformandosi nel corso degli ultimi venticinque anni.
A seguito della sottoscrizione del nuovo Contratto collettivo nazionale di Lavoro per il comparto Scuola, sarà inoltre necessario procedere alla redazione del Testo Unico coordinato del Contratto di comparto, che armonizzi, in un unico articolato coerente, tutte le norme pattizie vigenti, esistenti sulla materia”.
Nessun collegamento è rinvenibile tra un atto di indirizzo politico e un intervento legislativo di tale portata che viene richiamato da ogni Governo e mai realizzato. Peraltro, e coerentemente, non v’è traccia nella nota integrativa al bilancio del Ministero dell’istruzione 2021.
Perché, dunque, da due anni il Ministero dell’istruzione segue un iter programmatorio “anomalo”? Se facciamo una breve ricognizione dell’attività programmatoria delle altre amministrazioni centrali, riscontriamo una filiera logica trasparente che segue i dettami temporali e sequenziali definiti dalle norme. Lo stesso atto di indirizzo del Ministro dell’istruzione del 2019 risale al 20 dicembre 2018, prima dell’approvazione della legge di bilancio 2019. Successivamente, a seguito dell’approvazione della legge di bilancio, il Ministro ha emanato la direttiva annuale sull’azione amministrativa e la gestione, così come prevede l’art. 14 del d.lgs. 165/2001, secondo il quale il Ministro “….entro dieci giornidalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delleproposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuareed emana le conseguenti direttive generali per l'attivitàamministrativa e per la gestione….”.
Non si conoscono i motivi dell’anomala procedura. Sarebbe interessante, in questo momento davvero difficile anche dal punto di vista politico e istituzionale, conoscerne le motivazioni. La trasparenza deve riguardare anche la politica nella sua accezione più vicina ai cittadini, e i processi decisionali che abbiamo affrontato vanno tutti nella direzione della rendicontabilità, in ogni momento delle decisioni politiche.





.png) La Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO, organizza un corso di preparazione finalizzato al superamento delle prove scritte concorso dirigenti tecnici con possibilità di correzione degli elaborati
La Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO, organizza un corso di preparazione finalizzato al superamento delle prove scritte concorso dirigenti tecnici con possibilità di correzione degli elaborati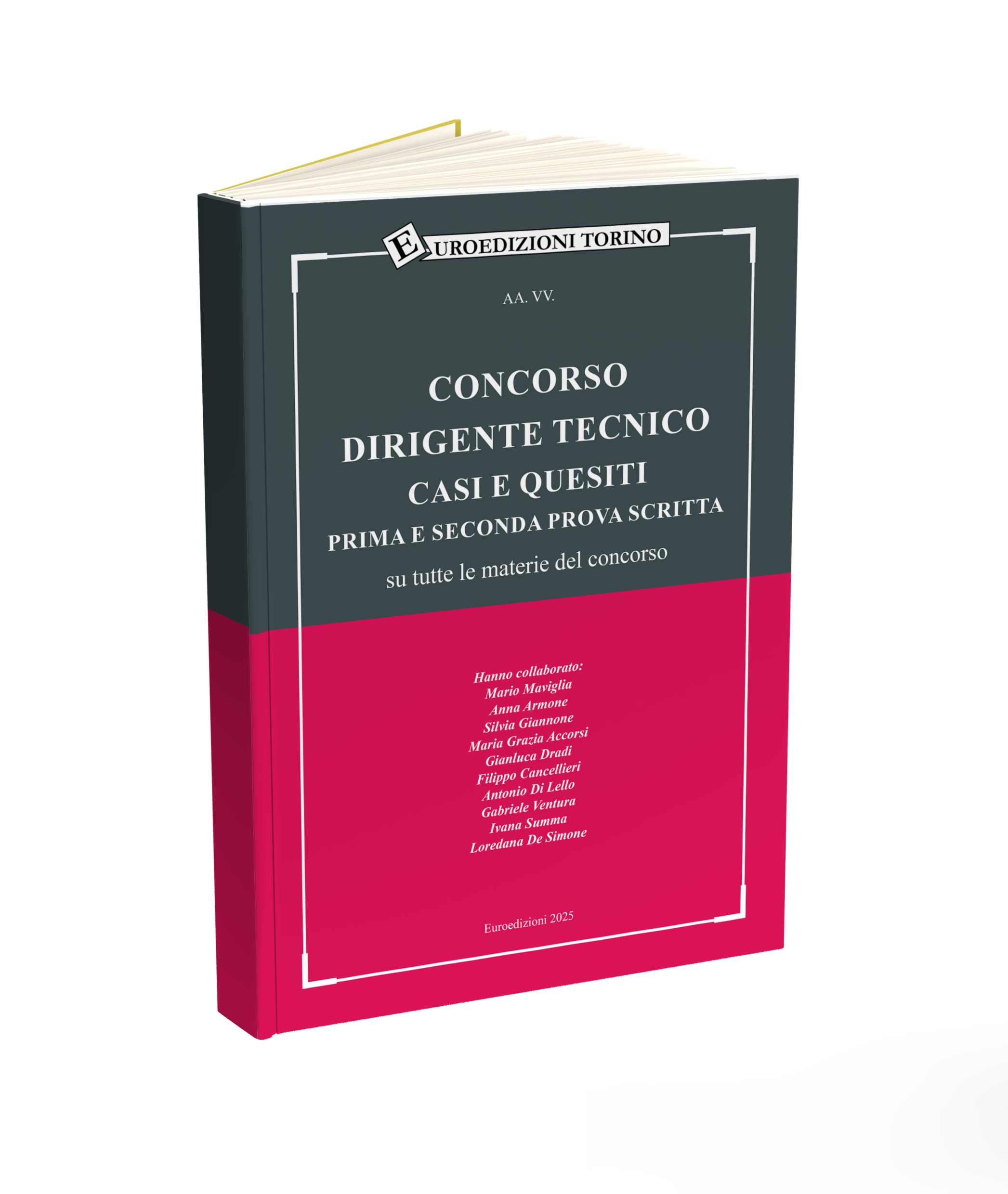 EUROEDIZIONI 2025 - Pagine 592 - Costo 36,00 euro
EUROEDIZIONI 2025 - Pagine 592 - Costo 36,00 euro COME FARE I PROVVEDIMENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE, DOCENTI DI RELIGIONE E DEL PERSONALE ATA
COME FARE I PROVVEDIMENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE, DOCENTI DI RELIGIONE E DEL PERSONALE ATA

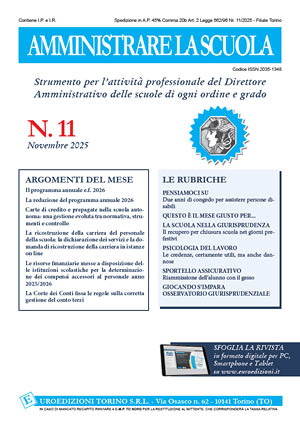
.png) E' stato pubblicato il bando di concorso relativo al reclutamento dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia, i posti messi a bando sono 27.376; si può partecipare in una sola regione. L’istanza è unica, specificando le tipologie di posto o i gradi d’istruzione per cui si possiede il titolo di accesso e si intende concorrere.
E' stato pubblicato il bando di concorso relativo al reclutamento dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia, i posti messi a bando sono 27.376; si può partecipare in una sola regione. L’istanza è unica, specificando le tipologie di posto o i gradi d’istruzione per cui si possiede il titolo di accesso e si intende concorrere. E' stato pubblicato il bando di concorso relativo alla scuola secondaria, i posti messi a bando sono 30.759; si può partecipare in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure su sostegno.
E' stato pubblicato il bando di concorso relativo alla scuola secondaria, i posti messi a bando sono 30.759; si può partecipare in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure su sostegno.

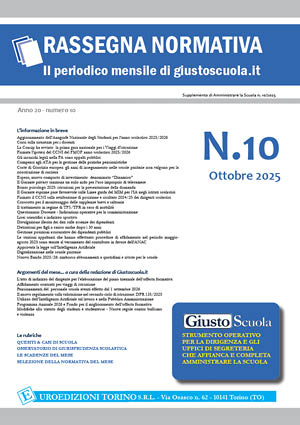
 Relatori: Le lezioni saranno tenute dalla D.ssa Antonietta Di Martino e Ing. Paolo Pieri autori del testo SALUTE e SICUREZZA NELLA SCUOLA Edito da Euroedizioni
Relatori: Le lezioni saranno tenute dalla D.ssa Antonietta Di Martino e Ing. Paolo Pieri autori del testo SALUTE e SICUREZZA NELLA SCUOLA Edito da Euroedizioni



.png)
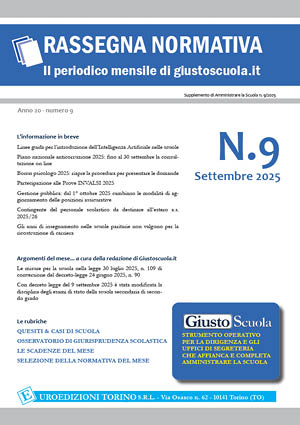
 La Casa Editrice EUROEDIZIONI propone un corso di formazione on line dal taglio pratico ed operativo destinato ai Direttori amministrativi anche di nuova nomina e agli Assistenti amministrativi facenti funzioni per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che il profilo gli assegna.
La Casa Editrice EUROEDIZIONI propone un corso di formazione on line dal taglio pratico ed operativo destinato ai Direttori amministrativi anche di nuova nomina e agli Assistenti amministrativi facenti funzioni per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che il profilo gli assegna.



 Un atto di indirizzo fuori tempo e fuori tema
Un atto di indirizzo fuori tempo e fuori tema




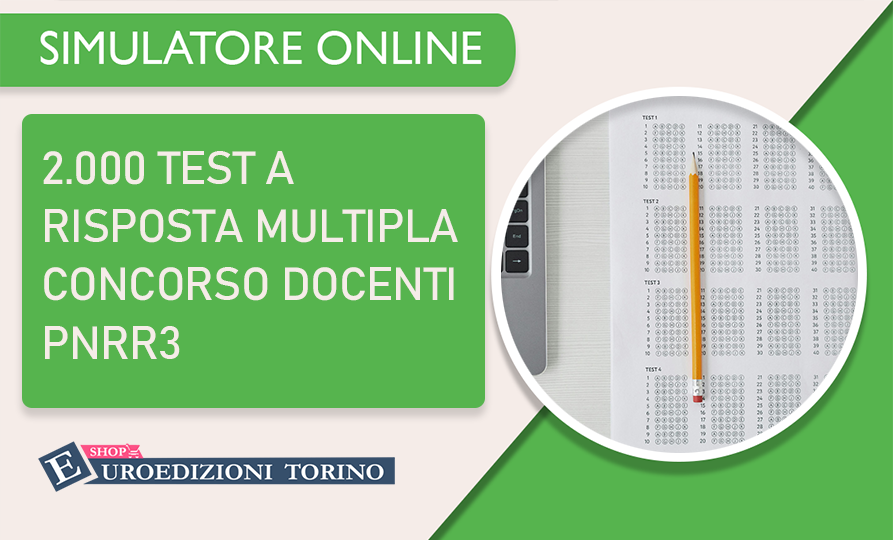
.png)






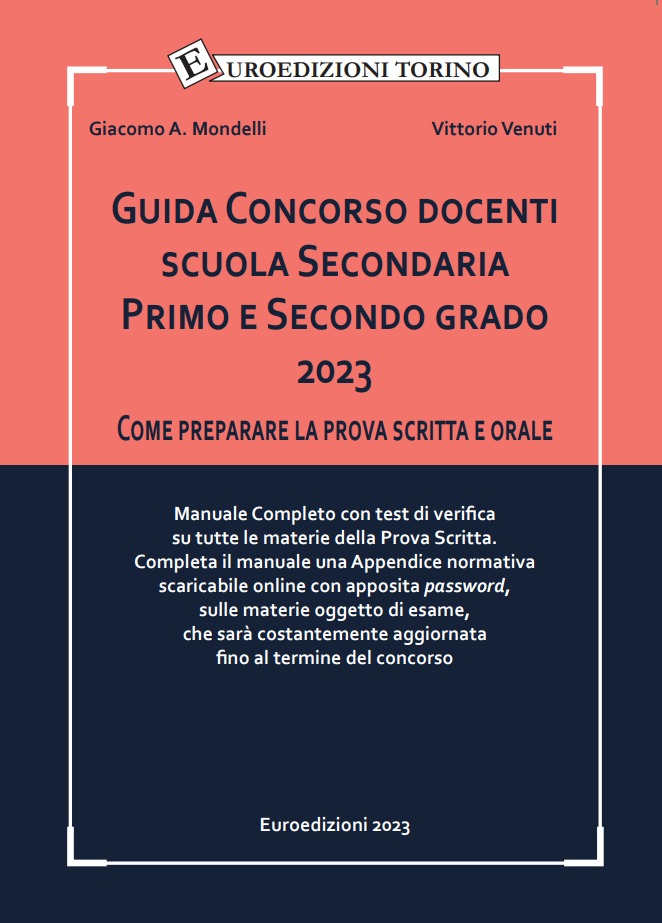
.jpg)







.png)
.jpeg)
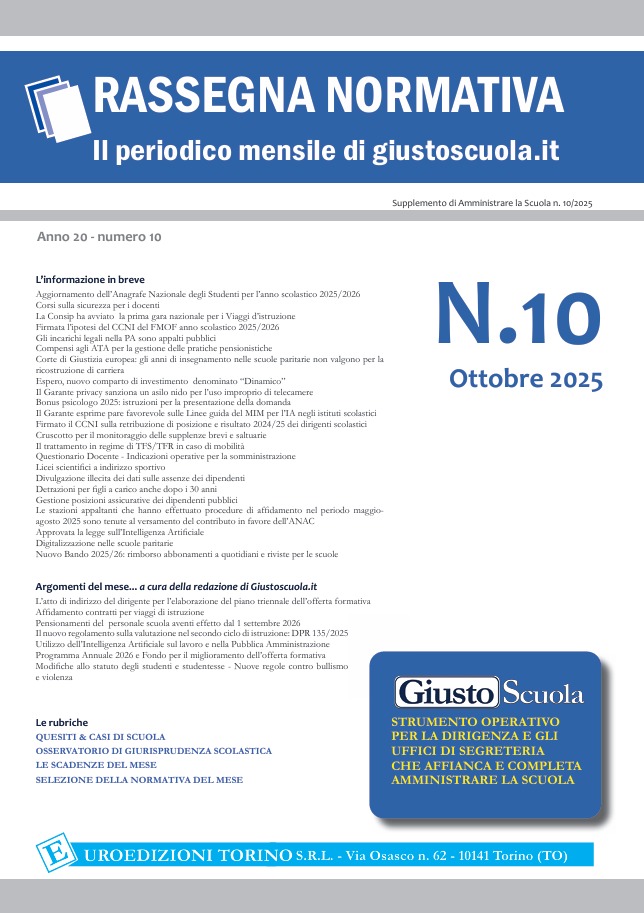
.png)



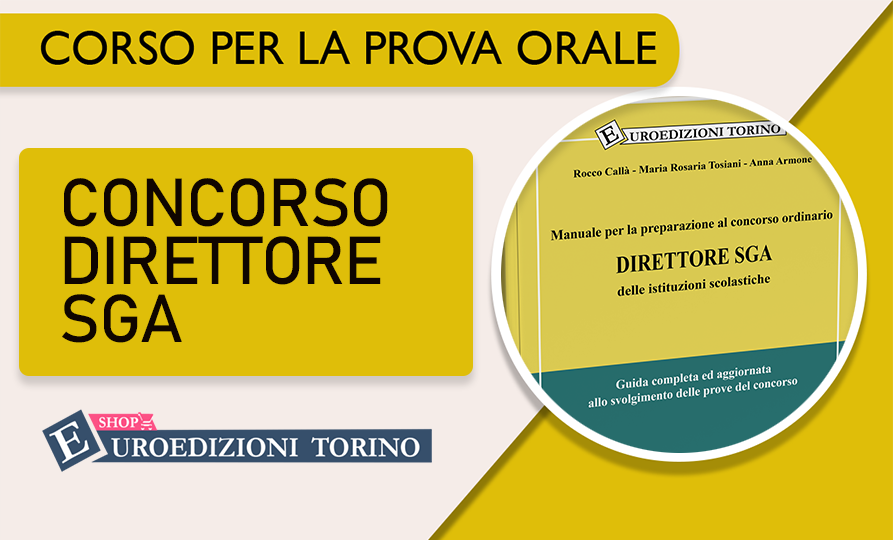
.jpeg)
.jpeg)



