Che anno scolastico sarà il 2025/2026?
Tra ritorni al passato e nuove incognite: la scuola italiana alla prova della riforma.
Editoriale a cura di Vittorio Venuti
Non si può dire che la riforma non sia partita. Un passo dopo l’altro, a balzelloni, è stato ridisegnato il quadro complessivo dell’istruzione, una sorta di mosaico che si è composto un po’ alla volta e che ha suscitato diffuse perplessità, critiche, prese di posizione, un po’ perché alcune novità sono state introdotte senza tener conto che si stava bypassando l’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, un po’ perché si sono evidenziate per lo spirito sanzionatorio che le sosteneva - in un ambiente che, di contro, privilegia l’aspetto educativo delle norme -, un po’ perché intenzionalmente orientate alla modificazione e sostituzione di documenti fondamentali (vedi: la proposta di riforma delle indicazioni nazionali 2025 per la scuola primaria), un po’ per l’evidente slittamento della organizzazione scolastica verso un passato rigenerato e inteso come la vera panacea per una scuola in disarmo (vedi la riforma dell’esame di Stato): tornare al passato guardando al futuro, un passato in cui il sacrificio, la disciplina e il merito si evidenziano come rimedi educativi indispensabili. Sarà così che la scuola, che noi stessi abbiamo definito in rotta verso il fallimento, si salverà e guiderà saldamente i nostri giovani verso un ridente avvenire?
Non possiamo che augurarcelo. Resta comunque più di qualche dubbio su quali intenzioni abbiano mosso la riforma in corso. L’ideologia che si intravvede suscita più di una qualche inquietudine, specialmente perché non si percepisce alcun chiaro riferimento socio-psicopedagogico, perché non mostra di avere validi riferimenti teorici. Si agisce senza far tesoro della storia della scuola, che si pensava definitivamente disancorata dalla riforma Gentile del 1923, anche perché i tempi non sono più gli stessi. È pur vero, però, che i tempi minacciano, ahimè, di esercitare la regola dei “corsi e ricorsi storici” di Vico.
Comunque vada, giacché amiamo la scuola nella sua complessità per il ruolo che ha nella società e amiamo i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, la gioventù che la frequenta, puntiamo ancora sulla sua migliore riuscita. Ma sarà dura!
Gli articoli di questo numero:
Pasquale Annese incentra la sua riflessione su una delle innovazioni introdotte dal ministro del MIM e che le scuole hanno dovuto affrontare in concomitanza dell’avvio dell’anno scolastico: il “Divieto dell’utilizzo dei cellulari in classe: un modello possibile”. Una questione controversa, complessa e divisiva, che ha trascinato con sé problematiche di varia natura: giuridica, organizzativa, metodologica, etica, di salute mentale.
Stefano Stefanel riprende la questione del divieto dell’uso dei cellulari in classe e pone l’interrogativo: “Ma il MIM può vietare qualcosa alle scuola?”. La nota che ha per oggetto “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione” è stata comunicata dal MIM come fosse una norma su cui non c’è nulla da discutere e rubricata come Circolare; fatto è che il MIM può agire attraverso Circolari solo sugli argomenti di sua totale competenza (le iscrizioni, ad esempio), non su azioni che competono all’autonomia scolastica.
Valentino Donà, informa che “Dall’anno scolastico 20252026 diventano strutturali le coperture assicurative INAIL per studenti e personale scolastico”, di fatto rendendo stabile la tutela assicurativa INAIL testata negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Si tratta di misura che interesserà 10 milioni di persone tra studenti e personale scolastico, docente e non docente di tutte le scuole italiane, e che si estenderà all’intero sistema formativo nazionale.
Laura Bertocchi e Mario Maviglia, nel contributo “Educare o reprimere. È questo il problema?” richiamano il caso degli studenti che, nel corso degli ultimi Esami di Stato, si sono rifiutati di sostenere la prova orale in segno di protesta contro una modalità che non condividono. Ciò nonostante, hanno ottenuto comunque il diploma grazie alla somma dei crediti e delle valutazioni delle prove scritte svolte fino a quel momento. Prontamente intervenuto sui fatti, il ministro dell’Istruzione ha assicurato che, dal prossimo anno scolastico, chi non si presenterà alla prova o farà scena muta sarà bocciato, come ribadito prontamente nel decreto legge n. 127/2025, che modifica l’esame di stato. Alla luce di tutto ciò, c’è da chiedersi se, pur discutibile la modalità scelta dagli studenti per manifestare il loro dissenso, il compito della scuola sia quello di educare o reprimere.
Antonietta Di Martino richiama l’attenzione su “Infortunio di un dipendente: quando è esclusa la responsabilità del datore di lavoro?”, materia che si appella all’obbligo imprescindibile della prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, tal che qualsiasi omissione in tal senso può comportare gravi conseguenze sia dal punto di vista penale che civile. Assume particolare rilievo il principio di responsabilità del datore di lavoro, come affermato dal D.lgs. n. 81/08, che assegna a questa figura obblighi la cui violazione è penalmente sanzionata.
Anna Armone presenta “Un caso di delitto di peculato a scuola a seguito dell’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio”. Il caso è quello di un’assistente amministrativa che ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che confermava la condanna per il delitto di peculato, commesso mediante l’appropriazione della somma di Euro 3.800, di cui aveva la disponibilità in qualità di assistente amministrativa, titolare ad interim delle funzioni di Direttore SGA presso un istituto scolastico. Segue l’interessante disamina dell’intero procedimento.
Filippo Cancellieri evidenzia, in “Gestione inclusiva e cura degli allievi plusdotati” la particolare situazione in cui si vengono a trovare i cosiddetti giftedchildren, allievi che si caratterizzano per essere ad alto potenziale cognitivo, rappresentano il 4 – 5% della popolazione scolastica, mediamente un allievo per classe,spesso con comportamenti problematici e difficoltà di adattamento. Il fenomeno è tale da richiedere l’approvazione di una legge a tutela degli allievi interessati, prevedendo anche azioni formative mirate per i docenti, le figure del referente e del tutor, quindi anche le procedure di certificazione e le misure didattiche personalizzate.
Maria Chiara Grigiante richiama l’attenzione su “L’intelligenza artificiale nella scuola: dall’uso sommerso alla necessità di una scelta di sistema”, evidenziando come tali strumenti siano già diffusi tra docenti e personale, sebbene spesso in forma silenziosa e non dichiarata. Assume rilievo lo scarto tra la retorica ufficiale e le pratiche quotidiane, che vedono l’AI impiegata per semplificare procedure burocratiche e didattiche. Particolare attenzione è rivolta al personale amministrativo, per il quale l’adozione trasparente può tradursi in un effettivo empowerment professionale. Più complesso il nodo didattico, tra timori di plagio e potenzialità innovative, che richiede una regolamentazione condivisa. Centrale, infine, l’esigenza di educare all’uso critico, superando l’attuale contraddizione tra diffidenza pubblica e impiego reale.
Carmelo Febbe e Angelo Orsingher trattano dei viaggi d’istruzione che rappresentano un momento fondamentale dell’autonomia scolastica, integrando le discipline curriculari con esperienze formative fuori dall’aula. La loro programmazione richiede però un’attenta pianificazione didattica, organizzativa e amministrativa, approvata dagli organi collegiali della scuola. Fondamentale è il rispetto delle normative ministeriali e delle disposizioni di sicurezza, che disciplinano responsabilità, accompagnatori e modalità operative.
Mario Di Mauro, per La Scuola in Europa, Presenta “Il Benelux e la sua magica memoria dell’antica Roma per una scuola tutta europea”. Esemplare il sistema educativo vissuto in ogni sua articolazione come una crescita partecipata anche se maggiormente strutturato nei due paesi più grandi, il Belgio e l’Olanda e con ciascuno a difesa nel contendersi sia la propria lingua che la propria storia assumendola come irrinunciabile in ogni suo aspetto. Non minore tuttavia l’impegno del Lussemburgo che sebbene il minore dei tre ha saputo conservarsi fiducioso in una sorta di eredità familistica ancora più vivace nel tenere insieme le ragioni millenarie di un continente di tradizione romana di cui è lo stesso Benelux ad esserne simbolo. Solo in Belgio tuttavia i costi di frequenza sono statali nelle scuole pubbliche fino ai 18 anni limitandosi negli altri due paesi ai 16 anni anche se con la possibilità in entrambi di richiedere in forma individuale assistenza e sostegno finanziario ‘ad personam’.
Vittorio Venuti, per Psicologia della Gestione, invita alla riflessione su “Alunni con disabilità e Progetto di vita”, prendendo spunto dal decreto legislativo n. 62 del 2024 in materia di disabilità, che si avvia già con la definizione stessa di disabilità e segnalando la dismissione delle denominazioni di handicap e di invalidità, privilegiando la locuzione “Persona con disabilità”, quindi l’importanza della valutazione di base, e l’elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Determinante appare il ruolo della scuola per quanto riguarda il riconoscimento della persona in sé sulla base del profilo di funzionamento elaborato dall’unità multidisciplinare: la persona e non la sua disabilità, i suoi punti di forza e non le sue fragilità, al fine di intercettare le sue potenzialità e farle evolvere attraverso le risorse in evoluzione di cui dispone, liberando il campo dagli ostacoli che potrebbero evidenziarsi e favorendo le migliorie più opportune.
Stefano Callà, per la rubrica I Casi della Scuola, propone “L’assegnazione dei docenti alle classi: quadro normativo, profili di legittimità e rischi applicativi”. Momento delicato della vita organizzativa di ogni istituzione scolastica, non è prerogativa assoluta del Dirigente Scolastico, ma di un procedimento scandito dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che coinvolge più organi e richiede un equilibrio organizzativo a tutela dei diritti dei singoli insegnanti.
Gianluca Dradi, per la Scuola nella giurisprudenza, tratta di “Molestie sessuali in classe e responsabilità del dirigente scolastico nella sua veste di datore di lavoro”, vicenda che ha origine in una scuola secondaria di primo grado, dove alcuni alunni subivano molestie sessuali da parte di un docente sia nelle ore di lezione che durante una gita scolastica. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello condannavano il Ministero, applicando l’art. 2049 c.c., a norma del quale il datore di lavoro è responsabile per i danni causati dai propri dipendenti nell’esercizio della loro attività lavorativa. La vicenda approda, infine, alla Corte di Cassazione.
Valentino Donà, per la rubrica Sportello Assicurativo, si sofferma sui profili assicurativi in caso di “Uscite didattiche in bicicletta”. A oggi, l’assicurazione per la Responsabilità Civile non è obbligatoria né per le biciclette tradizionali né per quelle a pedalata assistita. Tuttavia, il tema della sicurezza stradale è al centro delle riforme legislative, soprattutto in virtù del crescente numero di incidenti che coinvolgono mezzi di micro mobilità come, ad esempio, i monopattini. X





.png) La Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO, organizza un corso di preparazione finalizzato al superamento delle prove scritte concorso dirigenti tecnici con possibilità di correzione degli elaborati
La Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO, organizza un corso di preparazione finalizzato al superamento delle prove scritte concorso dirigenti tecnici con possibilità di correzione degli elaborati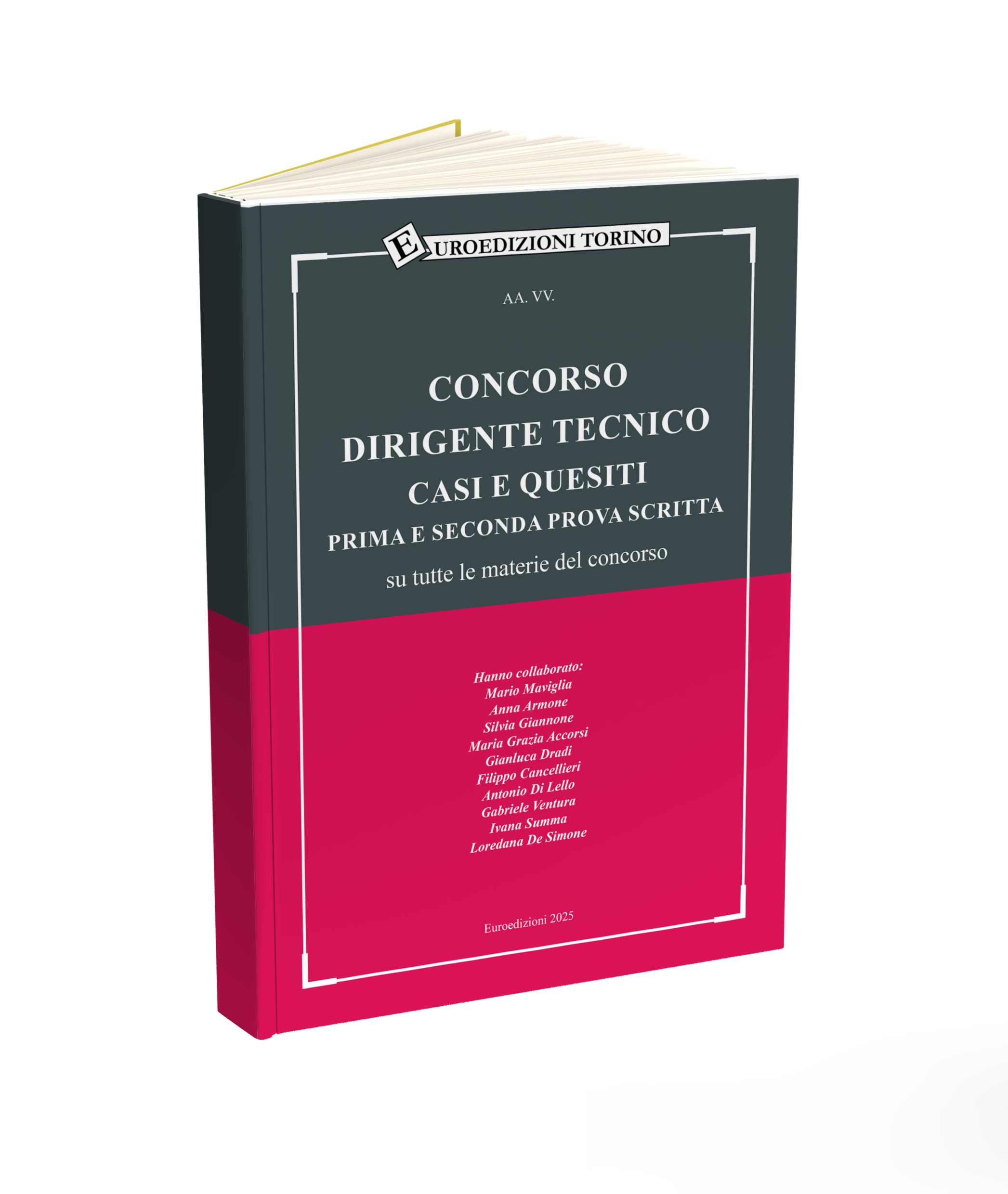 EUROEDIZIONI 2025 - Pagine 592 - Costo 36,00 euro
EUROEDIZIONI 2025 - Pagine 592 - Costo 36,00 euro COME FARE I PROVVEDIMENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE, DOCENTI DI RELIGIONE E DEL PERSONALE ATA
COME FARE I PROVVEDIMENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE, DOCENTI DI RELIGIONE E DEL PERSONALE ATA

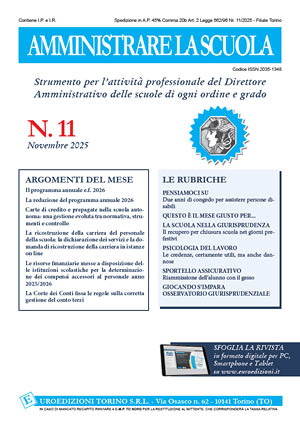
.png) E' stato pubblicato il bando di concorso relativo al reclutamento dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia, i posti messi a bando sono 27.376; si può partecipare in una sola regione. L’istanza è unica, specificando le tipologie di posto o i gradi d’istruzione per cui si possiede il titolo di accesso e si intende concorrere.
E' stato pubblicato il bando di concorso relativo al reclutamento dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia, i posti messi a bando sono 27.376; si può partecipare in una sola regione. L’istanza è unica, specificando le tipologie di posto o i gradi d’istruzione per cui si possiede il titolo di accesso e si intende concorrere. E' stato pubblicato il bando di concorso relativo alla scuola secondaria, i posti messi a bando sono 30.759; si può partecipare in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure su sostegno.
E' stato pubblicato il bando di concorso relativo alla scuola secondaria, i posti messi a bando sono 30.759; si può partecipare in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure su sostegno.

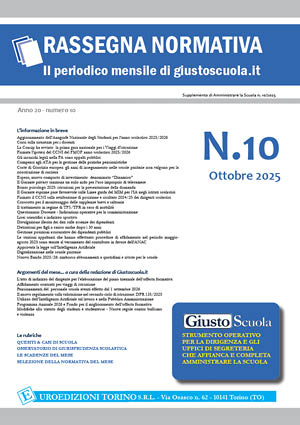
 Relatori: Le lezioni saranno tenute dalla D.ssa Antonietta Di Martino e Ing. Paolo Pieri autori del testo SALUTE e SICUREZZA NELLA SCUOLA Edito da Euroedizioni
Relatori: Le lezioni saranno tenute dalla D.ssa Antonietta Di Martino e Ing. Paolo Pieri autori del testo SALUTE e SICUREZZA NELLA SCUOLA Edito da Euroedizioni



.png)
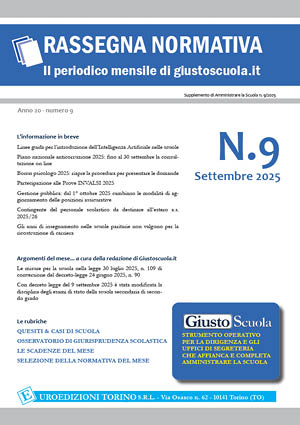
 La Casa Editrice EUROEDIZIONI propone un corso di formazione on line dal taglio pratico ed operativo destinato ai Direttori amministrativi anche di nuova nomina e agli Assistenti amministrativi facenti funzioni per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che il profilo gli assegna.
La Casa Editrice EUROEDIZIONI propone un corso di formazione on line dal taglio pratico ed operativo destinato ai Direttori amministrativi anche di nuova nomina e agli Assistenti amministrativi facenti funzioni per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che il profilo gli assegna.








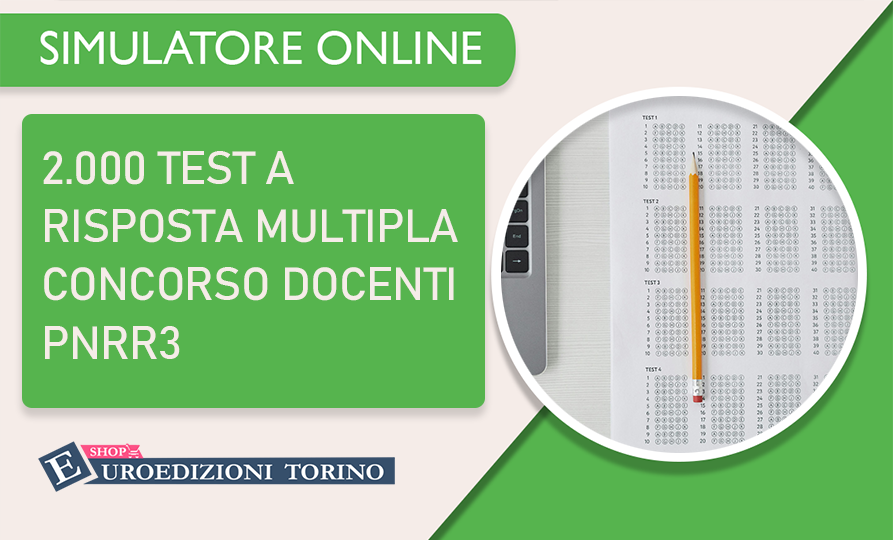
.png)






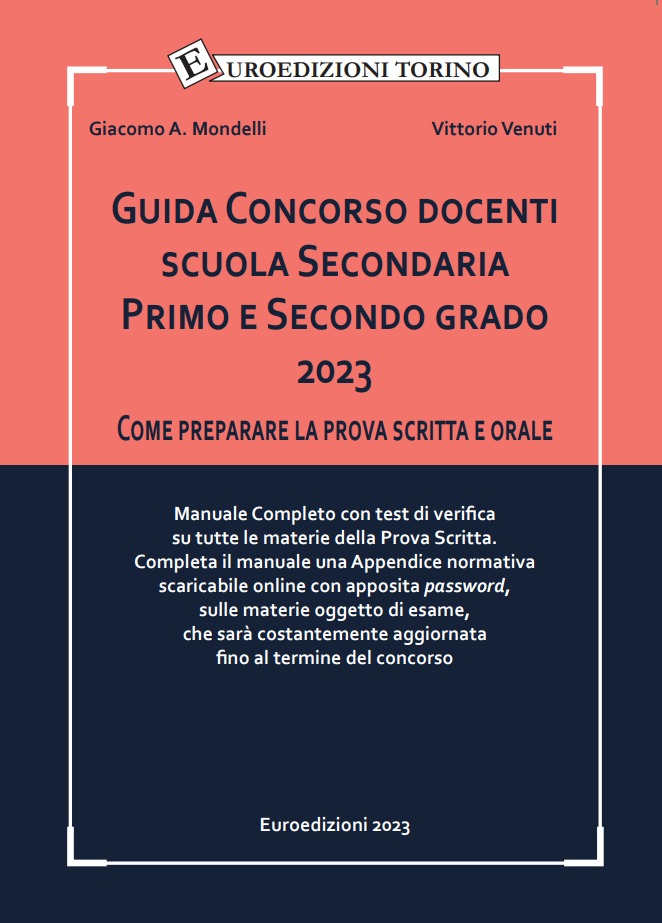
.jpg)







.png)
.jpeg)
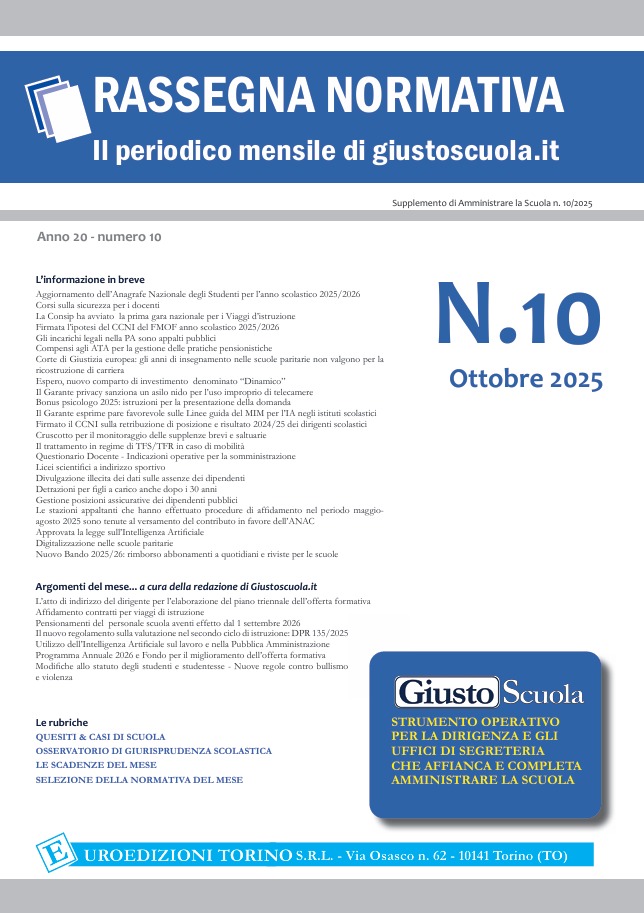
.png)



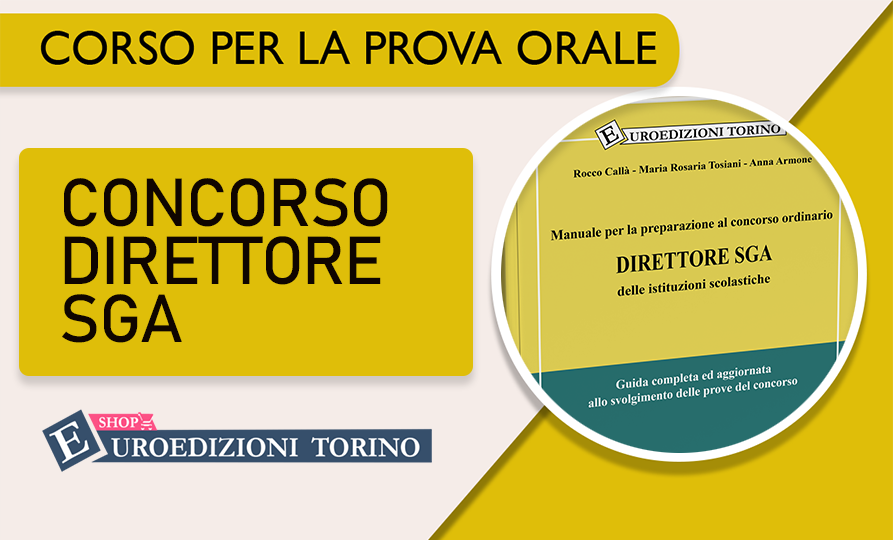
.jpeg)
.jpeg)



