DIRIGERE LA SCUOLE N. 9/2016
A un anno dalla riforma,cosa ne è della
“buona scuola”?
EditoriAle di vittorio venuti
Esattamente un anno fa, in questo stesso spazio, a seguito della legge 107/2015, proiettandoci di poco in avanti ci chiedevamo: “Sarà Buona Scuola?”.
Confidando nella premonizione, avevamo semplicemente presupposto: “Siamo certi di sì, non tanto per la riforma, per cui sembra che le contestazioni non si accennino a placare, quanto per il fatto che, come ogni anno, chi c’è a presidiare il proprio posto di lavoro e ad assumersi la responsabilità di rispondere nel miglior modo possibile – individualmente e come organizzazione scolastica – alle esigenze degli alunni è pronto a farlo con l’onestà di sempre, al di là di ogni polemica”. Alludevamo ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, al personale ATA, e anche quest’anno la nostra premonizione non può che esplicarsi nello stesso modo.
Le contestazioni non solo non si sono alleggerite ma è in fase di conclusione l’imponente raccolta di firme a sostegno di un referendum che attacca alcuni nodi cruciali della riforma, minacciata già all’indomani del varo della legge. Peraltro, sono stati attivati alcuni meccanismi (bonus premiale con annessi comitati di valutazione dalla composizione quantomeno discutibile, card del docente, Premio Nazionale Insegnanti) che certamente non hanno suscitato un riscontro favorevole; anzi, hanno ancor più alimentato il sospetto che l’Amministrazione continui a perseguire una via poco rispondente ai bisogni reali della scuola, come se viaggiasse su un altro versante. Inoltre, si è processato un Concorso Docenti tra incertezze e pressapochismo, annunci e smentite, che ha toccato il suo picco negativo nel trattamento economico riservato ai membri delle commissioni giudicatrici (da qualcuno definito alla stregua di un’elemosina), in una procedura per lo più mortificante per i precari che anche da più di un decennio lavoravano nella scuola, nella opacità dei criteri di valutazione.
Non si vuole negare che si siano avviate iniziative importanti, specialmente riguardo all’edilizia scolastica e all’assunzione di migliaia di docenti, ma non esprimono una chiara idea di scuola, come confermano le ultime esternazioni (in attesa di conferma) sul ritorno ai voti in lettere nella primaria e nella secondaria di primo grado, sull’uso dello smartphone in classe, senza che ci sia una seria riflessione pedagogica di fondo - come se la scuola potesse essere campo libero per personalismi, - e senza mai tener conto del quadro d’insieme della scuola. Anche la direttiva sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici si inserisce in questa logica di approssimazioni progressive: pur giusta nella sua essenza, cade in mezzo al campo scuola senza che sia inquadrata in un sistema di valutazione che comprenda il personale docente e Ata e nel quale il Dirigente recuperi il ruolo decisorio che gerarchicamente gli compete, essendo comunque il responsabile a tutti gli effetti dell’istituzione scolastica.
Dati positivi, dicevamo, ce ne sono. Il primo tra tutti, l’aver fatto entrare la scuola a far parte delle priorità dell’agenda politica del Governo, e poi ancora l’aver liberato fondi per il digitale con un piano d’investimenti e tempi di attuazione programmati; e poi ancora quanto è stato fatto sull’alternanza scuola/lavoro, certamente pregevole.
Ciò che lascia interdetti, però, è che non si coglie alcun progetto pedagogico, che le 90.000 assunzioni di cui va fiero il Miur (nelle more del giudizio del Consiglio europeo) sono state fatte senza alcuna verifica delle effettive capacità didattiche, che non si è avuto il coraggio di mettere mano agli organi collegiali, che non v’è traccia di una benché minima considerazione del personale ATA, che il numero delle scuole continui a contrarsi.
Ciononostante, la scuola riparte confidando nel personale che, sovraccaricato ulteriormente di richieste burocratiche, assicurerà ancora il “buon” funzionamento del sistema, perché la “buona scuola”, è il caso di ribadirlo, sono loro: dirigenti, docenti, personale amministrativo e non docente, tutti comunque impegnati a superare la demotivazione che si accompagna ad una riforma di cui non si comprende il disegno, come tutte le buone ed “epocali” riforme che si sono succedute negli ultimi venticinque anni.
Intervenendo al Giffoni Film Festival il 22 luglio scorso, il ministro Giannini ha sottolineato, con giusta enfasi, che la nostra “è un’ottima scuola, che ha alla base un principio di inclusione dal momento che cerca di non lasciare indietro nessuno. La società andrà dove la scuola la porta, per cui si tratta di una responsabilità enorme”. Pensiamo che la giusta interpretazione del concetto di inclusione debba ancora essere espressa, perché ancora si qualifica come sinonimo di integrazione, quanto a dire che la società andrà dove la scuola la porta, forse occorrerebbe tenere presente che la scuola rispecchia la società ed è l’esito delle politiche di governo, che raramente si confrontano con chi la scuola la fa tutti i giorni.
Questo numero della rivista si apre con un contributo di Ivana Summache, in “La buona scuola passa attraverso la valutazione”, evidenzia come tutto il sistema d’istruzione, con le migliaia di scuole autonome sparse su tutto il territorio nazionale, pare si voglia allineare intorno all’asse della valutazione, come si evince dalle suggestioni che derivano dall’INVALSI e dal RAV. Anche i dirigenti scolastici non sfuggono a questa scelta, essendo indiscutibile l’incidenza indiretta delle azioni di promozione, coordinamento, valorizzazione del personale, management delle risorse finanziarie e strumentali con la qualità e l’efficacia dell’offerta formativa di una scuola. Il tutto si inquadra in maniera decisa nella Direttiva MIUR del 14 giugno 2016 concernente la valutazione dei dirigenti scolastici, che – come da premessa - messa in relazione con “l’esigenza di valorizzare il Sistema Nazionale di Valutazione e di costruire un sistema organico per dirigenti scolastici e insegnanti nonché di diffondere la cultura della valutazione cui ancorare priorità formative e obiettivi dirigenziali”.
Sull’onda della valutazione Michela Lellapone l’accento sul fatto che la cultura del merito nel nostro Paese è scarsamente diffusa, con evidenti ripercussioni sul riconoscimento dei talenti e sulla valorizzazione delle competenze dei singoli. Quindi, nell’articolo “Entriamo nel Merito”, illustra i risultati di una ricerca sulla meritocrazia condotta da studiosi dell’Università Cattolica e che ha coinvolto dodici Paesi europei, avvalendosi di uno strumento da loro ideato per rilevare il merito in modo scientifico. L’Italia risulta saldamente in ultima posizione. Appare quanto mai significativo il fatto che tra gli elementi imprescindibili per rendere il nostro Paese più meritocratico venga segnalato, all’interno della qualità del sistema educativo, un corretto sistema di valutazione nella scuola.
A seguire, Giacinto Iannuzzipresenta la seconda parte dell’ampia riflessione su “L’eclissi dell’Etica”, in particolare riferendosi alla solitudine del Dirigente scolastico, che sembra essersi ancor più accentuata dai nuovi poteri attribuitigli dalla Legge n. 107/2015, che rischiano di metterlo in crisi mandandolo allo sbaraglio, alla mercé di troppi micro-poteri diffusi e interessati, di qualche contropotere “forte” presente anche nelle strutture dello Stato, di tante condizioni d’illegalità, a tutti i livelli, messe in atto da molti soggetti che trovano ampio spazio di azione proprio all’interno dell’apparato statale, e hanno altri scopi e altri obiettivi rispetto a un corretto funzionamento delle nostre Istituzioni.
Filippo Cancellieririflette su “La dimensione orientativa dei percorsi di scolarità: aspetti didattici e organizzativi”, avendo come spunto di avvio la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 2004 laddove riconduce all’orientamento quelle attività che contribuiscono “a mettere in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita, di identificare le proprie capacità, le proprie competenze, i propri interessi, di saper prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione, nonché di gestire i propri percorsi personali di vita nelle attività di formazione, nel mondo professionale e in qualsiasi ambiente in cui si acquisiscono e/o sfruttano tali capacità e competenze”, impostazione ribadita con “Lisbona 2010” e “Europa 2020”, nonché nelle “Linee Guida” del MIUR del 2009. Molto pertinente appare il riferimento al Progetto OR.M.E. (Orientamento nella Scuola Materna) avviato nell’a.s. 1997/98, a significare che l’azione di orientamento deve essere insita nel progetto didattico educativo lungo tutto l’arco degli apprendimenti, anche quelli più precoci.
Internet ha modificato radicalmente l’organizzazione e la gestione dei servizi e, insieme, anche della nostra vita, aprendoci ad un universo di possibilità e prospettive che si superano continuamente. I mezzi tecnologici per fruire di tali opportunità si fanno sempre più sofisticati e, se da un lato sono un tramite indispensabile per vivere e fruire del grande mare digitale, dall’altro richiedono una educazione continua per non“annegare”. L’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet è ineludibile, e nella scuola deve porsi alla base dell’insegnamento. Ciò, a maggior ragione tenendo conto che le nuove generazioni di studenti sono i cosiddetti “nativi digitali”, che armeggiano già in tenera età con telefoni ultima generazione e tablet. Daniela Decembrinoillustra ampiamente e con chiarezza tutte le opportunità didattiche offerte dalle TIC in “Didattica multimediale e competenze digitali dell’insegnante per potenziare la qualità degli apprendimenti degli studenti”.
Edgardo Escamiloci intrattiene sulle responsabilità dirigenziale col preciso scopo di delimitarne i confini ed evidenziarne la relazione con le responsabilità dal significato strettamente giuridico. In “Aspetto fisiologico nella responsabilità dirigenziale” si pone in particolare evidenza il fatto che il dirigente porta con sé la responsabilità, i cui connotati vanno ricercati non già nel glossario giuridico conosciuto quanto nell’espletamento delle stesse funzioni dirigenziali, che sono concepite per la realizzazione di obiettivi e risultati.
Come ogni anno per i dirigenti di molti Istituti Scolastici si pone la necessità di valutare quali contratti di servizi attivare per il corretto funzionamento del proprio Istituto e tra questi assume particolare rilevanza quello per i servizi assicurativi a protezione di alunni e docenti e dei beni di proprietà. Nel contributo dell’ Avvocato Stefano Feltrin“I contratti per servizi assicurativi degli istituti scolastici” viene offerta una guida operativa per lo svolgimento della procedura per l’affidamento dei contratti assicurativi alla luce delle norme introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo n.50/2016. Il Dirigente, infatti, dopo aver adeguatamente valutato a quali rischi concreti è esposto l’Istituto e quali coperture risultano più adeguate a garantire la sicurezza di alunni e docenti, deve procedere all’individuazione della polizza per gli alunni ed il personale della scuola attraverso una delle procedure previste dal vigente ordinamento in materia di affidamento di contratti di appalto di servizi pubblici.
Per la rubrica CPIA, Ada Maurizio intervista lo scrittore Eraldo Affinati, inserito nella cinquina dei finalisti del Premio Strega e arrivato secondo con il romanzo “L’uomo del futuro”. Affinati, giunto al diciassettesimo romanzo, ha una lunga esperienza di insegnante nella scuola pubblica, nel 2008 ha anche fondato a Roma la scuola per imparare l’italiano“Penny Wirton”. L’intervista è strutturata attorno al tema dell’immigrazione considerato dal punto di vista storico/evolutivo e pedagogico/didattico.
Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauroci introduce nel clima danese con “Tra riforme e bilanci, anche la Danimarca cerca la scuola vincente?” La Danimarca ha sviluppato nel tempo un diffuso benessere sociale in tutto il paese con una attenzione continua all’istruzione intesa come sistema di promozione individuale e sociale da mantenere vivo e diffuso tra tutti, grazie a riforme che hanno saputo armonizzare soluzioni innovative nel rispetto dei costumi e delle attese sociali, oltre che in un profondo senso di responsabilità e di autonomia.
Per la rubrica di Psicologia della Gestione, Vittorio Venuti pone l’interrogativo “Se fosse vero che la scuola è sbagliata?”, recuperando la riflessione sulla scuola di un quattordicenne che nell’anno scolastico appena trascorso ha ripetuto per la seconda volta la prima media ma avendo già in carriera anche una bocciatura in quinta elementare, nonostante sia dotato di apprezzabile intelligenza e si muova nel mondo informatico con una padronanza invidiabile. I responsabili del sistema d’istruzione sono chiamati a riflettere sul vero senso della scuola uscendo dai limiti culturali e strutturali correnti per tracciare il disegno di una scuola che sia veramente luogo di apprendimento e di crescita per tutti.
Per Giurisprudenza del Lavoro, il consueto, interessante contributo di Rosanna Visocchi. X





 Una panoramica completa e operativa sul processo di inclusione scolastica
Una panoramica completa e operativa sul processo di inclusione scolastica Un nuovo corso che fornisce a Dirigenti Scolastici, DSGA, docenti accompagnatori e referenti di plesso un quadro completo, operativo e aggiornato sulla corretta gestione dei Viaggi di Istruzione, dalla progettazione alla fase esecutiva. A partire dalle premesse normative e giuridiche sulla vigilanza scolastica, vengono illustrate le responsabilità di scuola e personale, le regole di condotta, gli adempimenti amministrativi e le procedure necessarie per garantire sicurezza, trasparenza e conformità alla normativa vigente.
Un nuovo corso che fornisce a Dirigenti Scolastici, DSGA, docenti accompagnatori e referenti di plesso un quadro completo, operativo e aggiornato sulla corretta gestione dei Viaggi di Istruzione, dalla progettazione alla fase esecutiva. A partire dalle premesse normative e giuridiche sulla vigilanza scolastica, vengono illustrate le responsabilità di scuola e personale, le regole di condotta, gli adempimenti amministrativi e le procedure necessarie per garantire sicurezza, trasparenza e conformità alla normativa vigente.





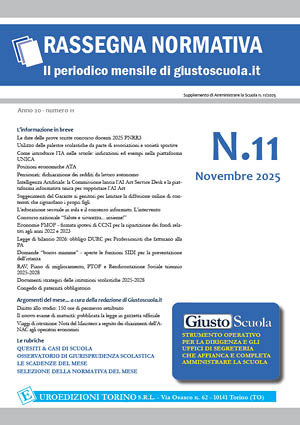
 Come rispettare in modo puntuale gli obblighi di pubblicazione previsti entro il 30 novembre?
Come rispettare in modo puntuale gli obblighi di pubblicazione previsti entro il 30 novembre?

.png) La Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO, organizza un corso di preparazione finalizzato al superamento delle prove scritte concorso dirigenti tecnici con possibilità di correzione degli elaborati
La Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO, organizza un corso di preparazione finalizzato al superamento delle prove scritte concorso dirigenti tecnici con possibilità di correzione degli elaborati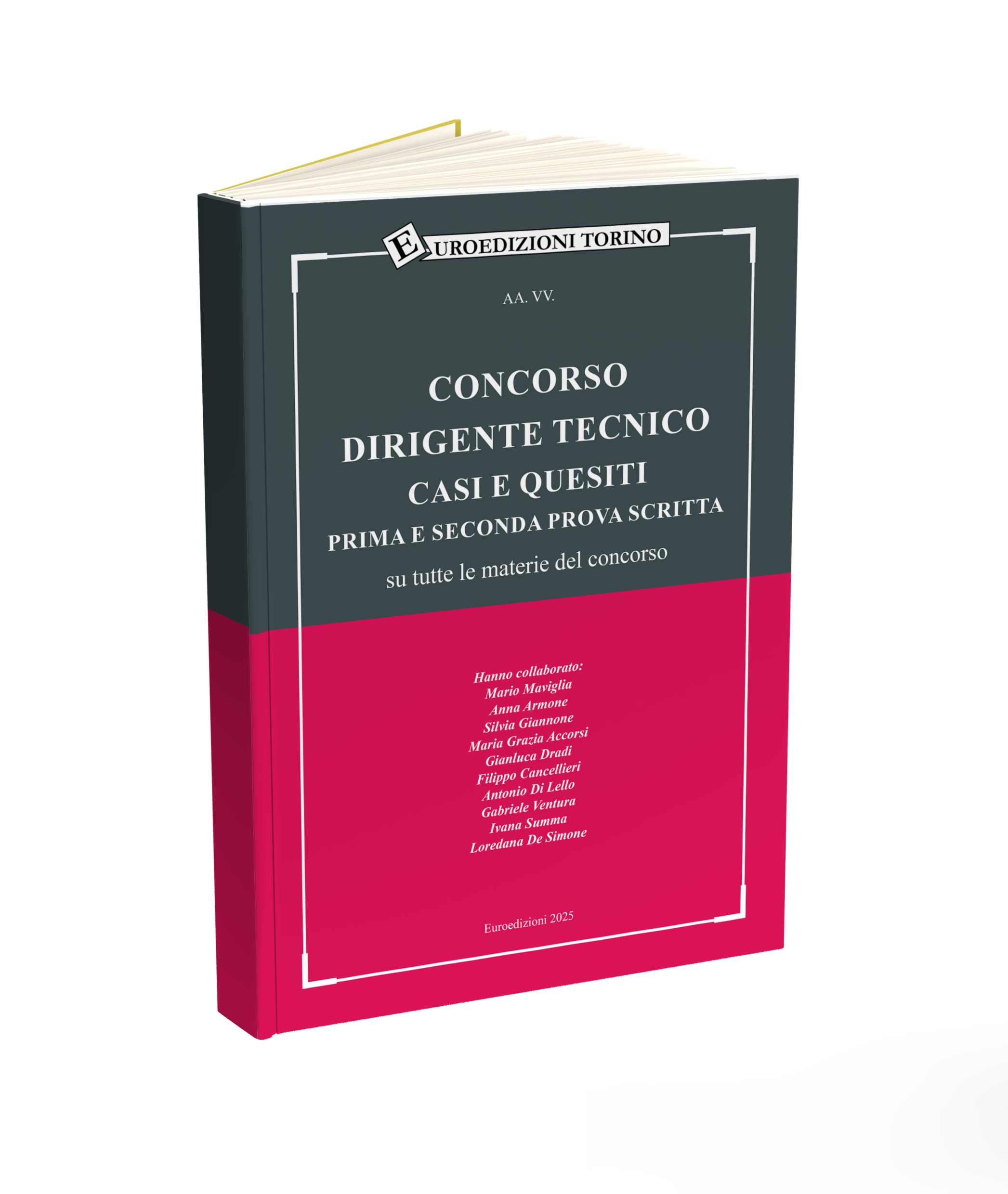 EUROEDIZIONI 2025 - Pagine 592 - Costo 36,00 euro
EUROEDIZIONI 2025 - Pagine 592 - Costo 36,00 euro COME FARE I PROVVEDIMENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE, DOCENTI DI RELIGIONE E DEL PERSONALE ATA
COME FARE I PROVVEDIMENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE, DOCENTI DI RELIGIONE E DEL PERSONALE ATA
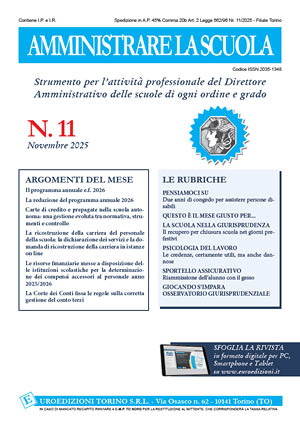
.png) E' stato pubblicato il bando di concorso relativo al reclutamento dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia, i posti messi a bando sono 27.376; si può partecipare in una sola regione. L’istanza è unica, specificando le tipologie di posto o i gradi d’istruzione per cui si possiede il titolo di accesso e si intende concorrere.
E' stato pubblicato il bando di concorso relativo al reclutamento dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia, i posti messi a bando sono 27.376; si può partecipare in una sola regione. L’istanza è unica, specificando le tipologie di posto o i gradi d’istruzione per cui si possiede il titolo di accesso e si intende concorrere. E' stato pubblicato il bando di concorso relativo alla scuola secondaria, i posti messi a bando sono 30.759; si può partecipare in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure su sostegno.
E' stato pubblicato il bando di concorso relativo alla scuola secondaria, i posti messi a bando sono 30.759; si può partecipare in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure su sostegno.

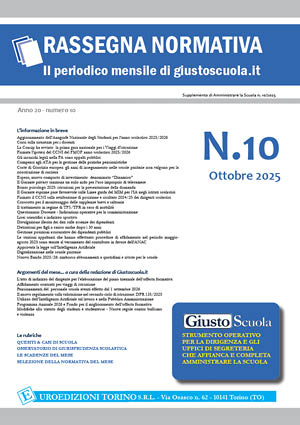
 Relatori: Le lezioni saranno tenute dalla D.ssa Antonietta Di Martino e Ing. Paolo Pieri autori del testo SALUTE e SICUREZZA NELLA SCUOLA Edito da Euroedizioni
Relatori: Le lezioni saranno tenute dalla D.ssa Antonietta Di Martino e Ing. Paolo Pieri autori del testo SALUTE e SICUREZZA NELLA SCUOLA Edito da Euroedizioni
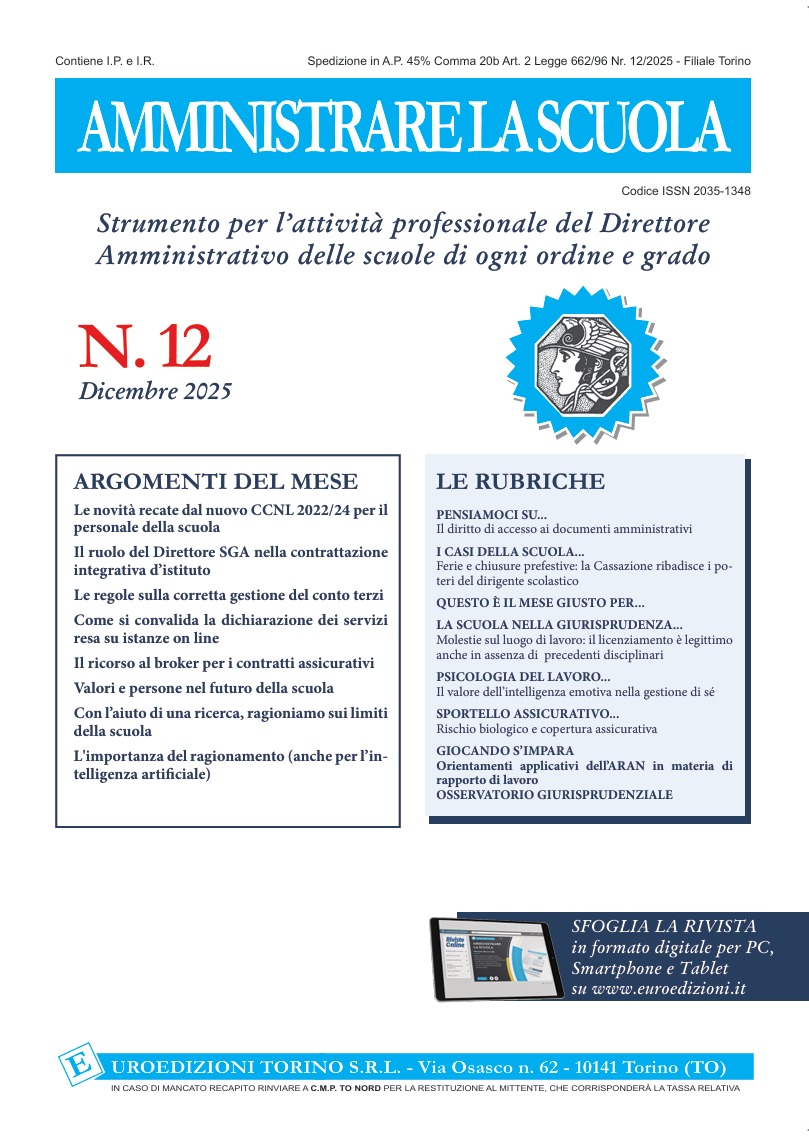


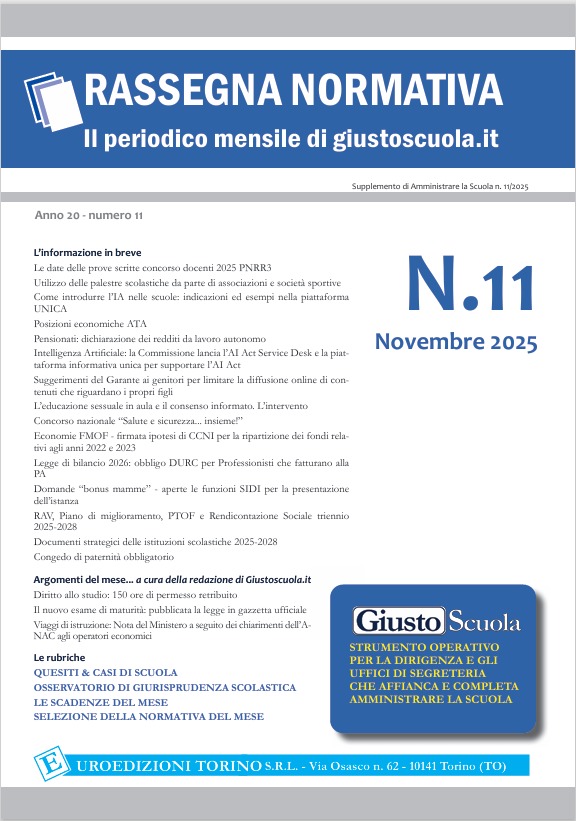
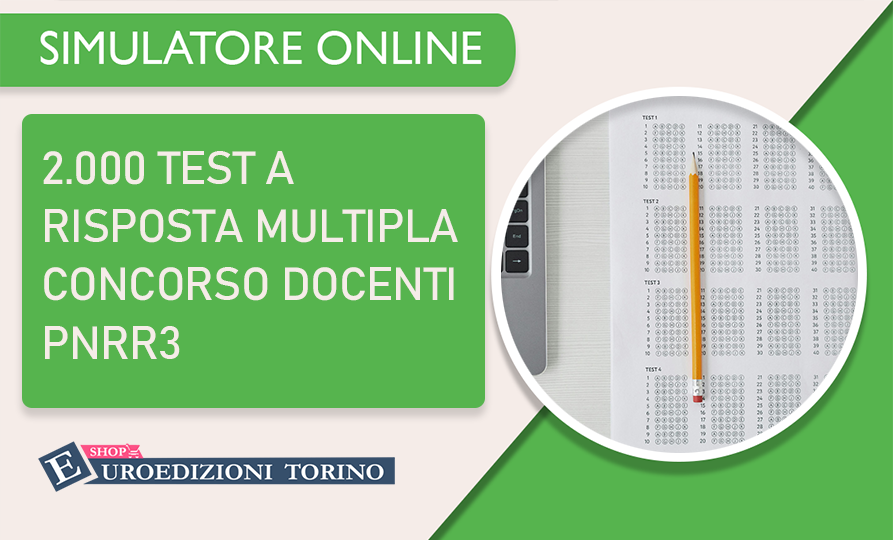
.png)






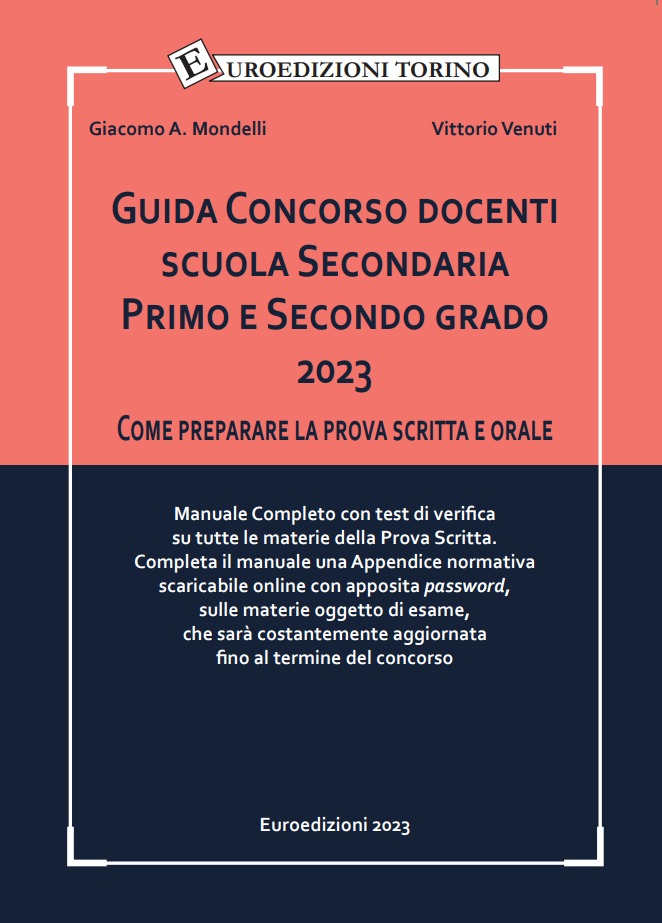
.jpg)





.png)
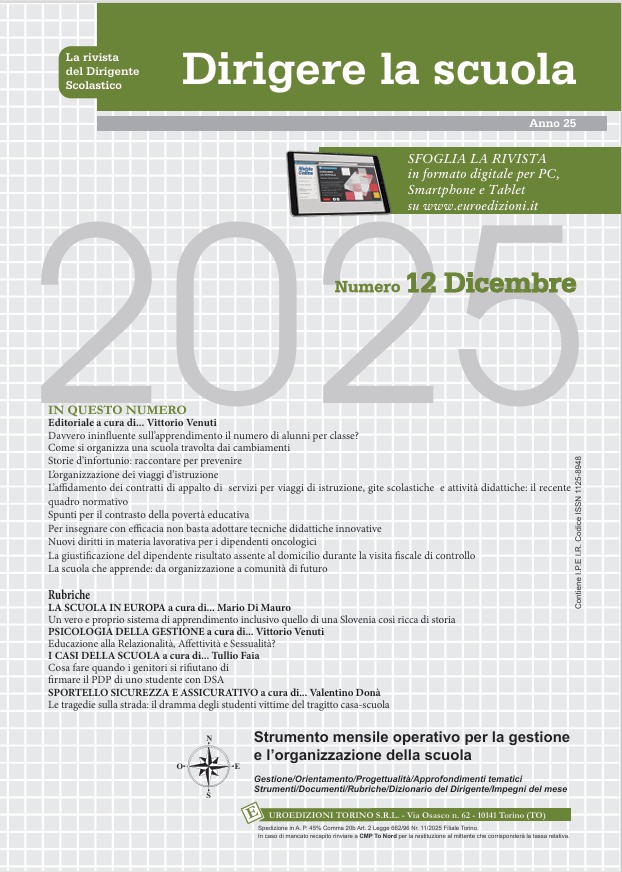
.png)
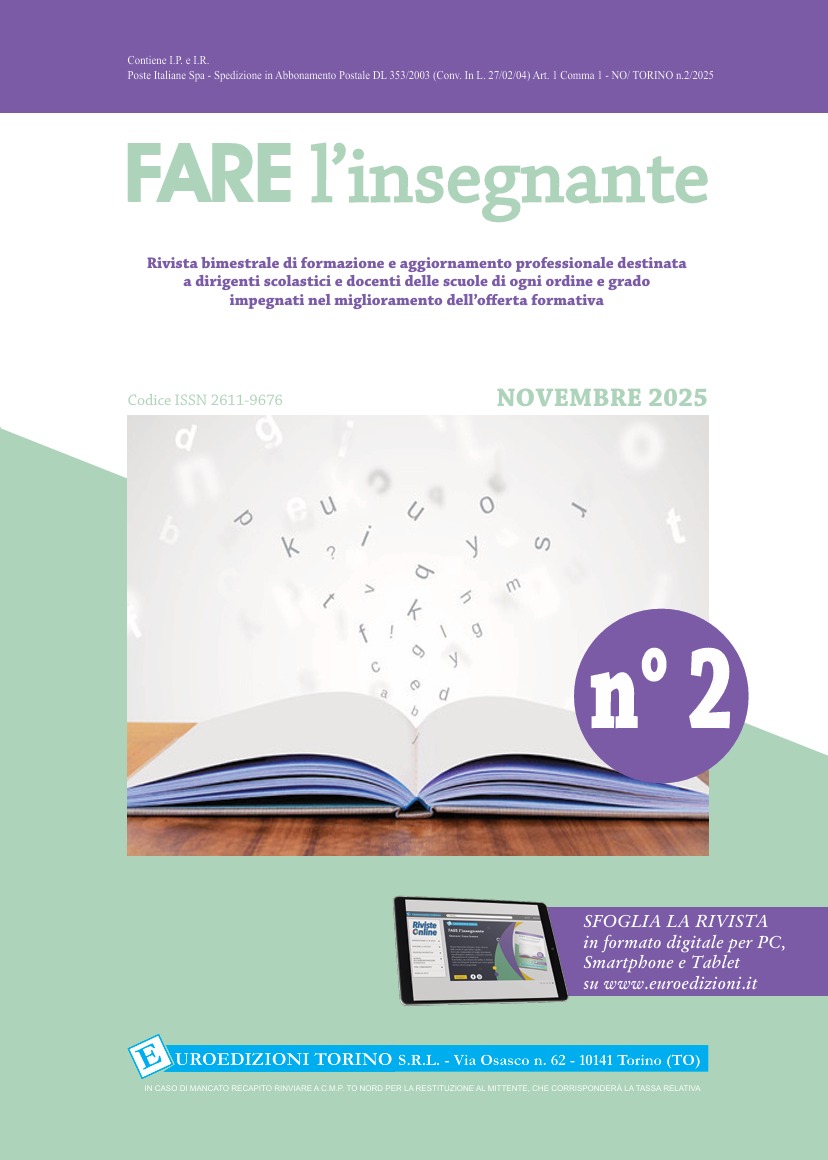
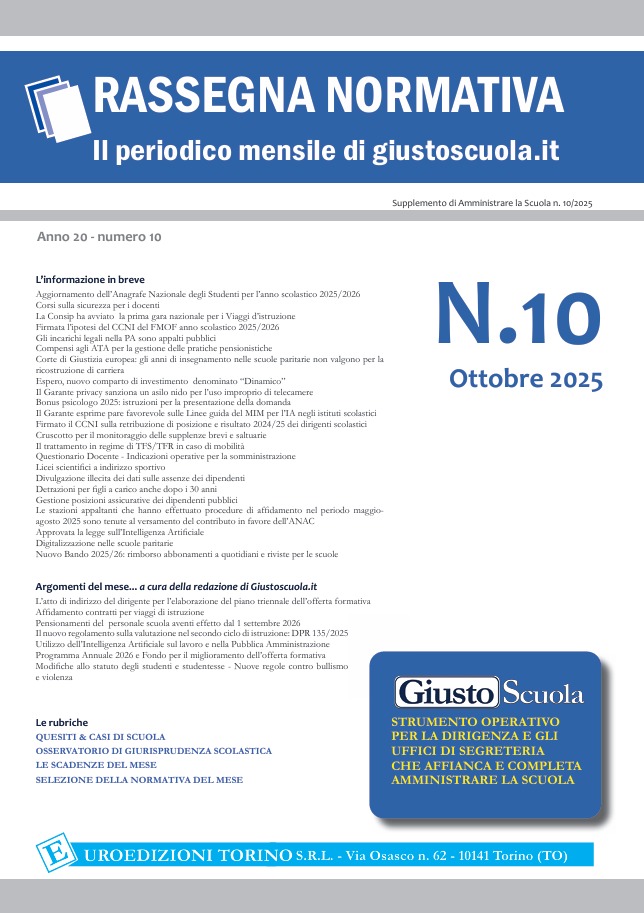
.png)



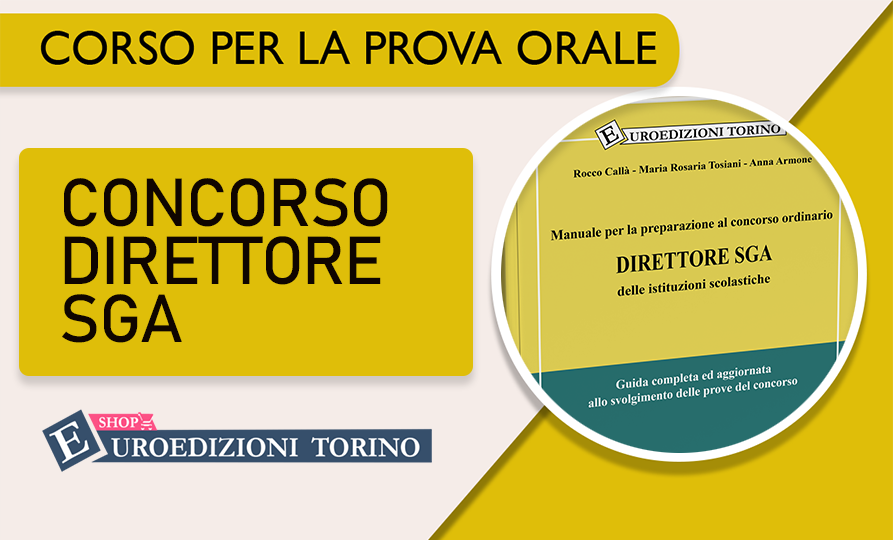
.jpeg)
.jpeg)



