
 Dirigere LA SCUOLA N.11/2021
Dirigere LA SCUOLA N.11/2021
La classifica di Eduscopio e l’impossibile riduzione degli alunni per classe
Editoriale di Vittorio Venuti
Siamo, infine, arrivati al termine di quest’anno 2021 e i nodi strutturali della scuola permangono pressoché immutati; ogni tanto la luce di qualche intuizione, il riverbero di una intenzione, la promessa di mettere mano su questo o su quello - purché a costo zero per l’Amministrazione -, ma il quadro rimane sostanzialmente inalterato, ancora ostaggio di una pandemia che non accenna a regredire definitivamente.
Colpisce che Eduscopio, creatura che fa capo alla Fondazione Agnelli, abbia ancora voglia di mettere bellamente in fila, secondo “merito”, le scuole secondarie di secondo grado alla luce di criteri e parametri che dovrebbero apparire obiettivi, ma di cui, francamente, non si apprezzano costrutti al di là dell’insistenza a voler definire la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari, nonché la capacità di istituti tecnici e professionali di preparare l’ingresso nel mondo del lavoro per quanti, dopo il diploma, hanno più interesse a trovare un impiego. In sostanza, una lettura strumentale del naturale procedere dell’istruzione secondaria, come ad ispirarne la curvatura dell’impianto pedagogico e didattico verso l’orizzonte più speculativo del mercato.
I dati che il gruppo di lavoro di Eduscopio ha analizzato si riferiscono a 1.267.000 diplomati italiani di 7.500 scuole in tre successivi anni scolastici (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), indubbiamente un ampio campione, ma, nello specifico, c’è da dire che le graduatorie fanno male alla scuola, soprattutto quando, come nel caso, non tengono conto delle diverse realtà che la compongono e le forti disuguaglianze che la definiscono in ordine agli stessi istituti presi in considerazione, alle regioni, ai territori, alle culture e alle rilevanze socioeconomiche nelle quali si trovano ad agire.
Alla comparsa delle graduatorie, che finiscono col favorire la competizione tra gli istituti, sui social si è sollevato un partecipato atteggiamento di rigetto da parte dei dirigenti scolastici, che si possono sintetizzare in pochi semplici punti interrogativi: A cosa servono? A chi giovano e perché? Quale beneficio dovrebbe derivarne alle scuole e perché? Di fondo, ancora, la confusione che regna intorno alla missione della scuola, sulla quale sembra che tutti sappiano qual è o dovrebbe essere, meno che la scuola stessa.
Il dibattito sull’argomento, comunque, si è esaurito ben presto. All’orizzonte si è affacciata la notizia, enfatizzata dai media “Diminuzione numero alunni per classe: la legge di bilancio dice di sì, ma ad organico invariato”.Una promessa che implica una contraddizione. Come si fa, infatti a ridurre il numero degli alunni per classe senza prevedere un aumento dell’organico? E qui entra in campo la ferrea regola del “a saldi invariati”. Difatti, la pubblicazione della relazione tecnica allegata al provvedimento ha “smontato” le molte aspettative che la notizia aveva suscitato.
Confermato che la misura non prevede alcuna risorsa aggiuntiva, scopriamo che la stessa si collega ai dati Istat, che confermano il netto calo della popolazione scolastica, calo che, di per sé, si tradurrebbe in una diminuzione del rapporto numerico alunni/docenti. Ragion per cui - sostengono i tecnici ministeriali -, agendo con accortezza su questo calo si potrebbe diminuire il numero degli alunni per classe nelle situazioni più critiche, pervenendo anche ad un aumento del numero delle classi esclusivamente nelle scuole che già dispongono degli spazi necessari. Possibile, dunque, ma purché la creazione di classi più piccole non comporti maggiori spese indirette. Il tutto nelle more di un apposito decreto ministeriale da adottarsi, per l’anno scolastico 2022/2023, entro il mese di marzo 2022. Per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 entro il mese di febbraio. Al termine dell’anno scolastico 2024/2025 il Ministero dell’Istruzione effettuerà una valutazione dei risultati previsti dal provvedimento.
Augurabile che, al di là delle scadenze prefissate, si individuino altre modalità, meno di facciata, per affrontare la questione, se davvero la si ritiene seria e degna di essere tenuta in considerazione, così da farla rientrare in un progetto organicodi riforma del sistema d’istruzione.
Panoramica degli articoli di questo numero.
Sandro Valente ci ricorda che il termine per la predisposizione de “Il Programma Annuale 2022”è stato rinviato al 15 gennaio 2022, quindi dibatte su questo che rappresenta il principale strumento di gestione attraverso il quale vengono programmate le operazioni finanziarie che l’istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell’anno solare, il cui punto di origine riconduce inevitabilmente al PTOF. Rilievo di particolare importanza assume la relazione che accompagna il documento e di cui viene offerto all’attenzione un articolato schema tipo.
Michela Lella, in “Continuiamo a far finta che vada tutto bene?”, riflette sulla responsabilità del sistema nazionale di istruzione e formazione ritenendo che non sia attribuibile unicamente alle scelte politiche e governative, ma sia attribuibile anche alla condivisione e alla partecipazione di tutti i soggetti interessati al destino delle giovani generazioni. La scuola è un’istituzione che muove una responsabilità collettiva: i suoi fallimenti, dunque, sono insuccessi di una società che non si prende cura dell’istruzione e dell’educazione dei ragazzi e dei giovani.
Giacomo Mondelli propone la prima parte di “Dalle criticità della pandemia a una scuola migliore. Ovvero, verso una scuola per gli adolescenti”.L’abbrivio trae spunto dalla considerazione che le opzioni educative e formative, adottate in questa fase emergenziale da un buon numero di scuole, possano costituire una valida occasione per pensare e riflettere su due questioni fondamentali e tra loro strettamente connesse: da una parte e in generale, sulla individuazione delle modalità di “fare scuola” più adeguate ed efficaci e, dall’altra parte, persino, sulla ridefinizione del profilo complessivo della scuola secondariae, quindi, sulla sua identità educativa e formativa.
Anna Armonedibatte su “Le clausole contrattuali tipo per il titolare e il responsabile del trattamento dei dati personali stabilite dall’UE”,quindi tratta dell’accordo che riguarda esclusivamente il responsabile esterno, che assume, rispetto al passato, tutt’altra rilevanza, in quanto il Regolamento gli conferisce una connotazione quasi professionale. Difatti, non è più prevista la vecchia figura del responsabile interno del trattamento contenuta nel Codice della Privacy. La relazione illustrativa del decreto prevede che Titolare e Responsabile abbiano il potere di delegare compiti e funzioni a persone che operano sotto la loro autorità.
Paolo Pieri incentra il suo intervento su“Securitas quale effetto del Bene Comune”, avviandolo dalla etimologia della parola sicurezza e conducendolo tra iconografia, storiografia e letteratura, dagli antichi Romani al Medioevo, al fine di indurre una pertinente riflessione sulla costruzione e gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro di oggi.
Luciana Petrucci Ciaschini presenta la prima parte de “L’anno di formazione e di prova del personale docente”.Richiamando la normativa di merito, il contributo illustra i passaggi che caratterizzano questo importantissimo tassello della carriera docente: che cosa occorre per superare l’anno di formazione e prova; le attività di formazione; peer to peer - formazione tra pari; formazione on line; portfolio professionale; docente tutor.
Mario Di Mauro, per la Scuola in Europa, pone l’interrogativo “Quanto è facile oggi spuntarla come ‘sistema educativo’ in Europa?”. La disamina del problema pone al centro il New Education Forum, attivo da sei anni e riconosciuto come il luogo di dibattito più ricercato per mettere in cantiere ogni possibile novità. Il NEF si qualifica come l’occasione europea più importante per l’innovazione su piattaforma, novità che attribuisce ad ogni scambio un valore aggiunto, che può riguardare l’istruzione come sistema nel suo complesso ma anche come formazione nelle sue dimensioni più spiccatamente socio-professionali.
Vittorio Venuti, per Psicologia della Gestione, propone “Il progetto di vita degli alunni con disabilità”, rilevando l’importanza, per la scuola, di considerare gli alunni con disabilità nella loro urgenza di riconoscimento come persone in crescita, che devono vedersi riconosciuto il diritto alla garanzia e all’assicurazione del loro processo esistenziale. La scuola non può ignorare la sua funzione integrazionale ed inclusiva, formativa ed orientativa, che deve essere esercitata su tutti gli allievi al di là di ogni loro caratterizzazione fisica, psichica, sociale.
Antonio Di Lello, per I Casi della Scuola, propone alla lettura “Refezione scolastica”,riprendendo una sentenza del 2018 del Consiglio di Stato, che si è pronunciato negativamente sull’appello del Comune di Benevento avverso alla sentenza del TAR Campania, che aveva accolto il ricorso di un gruppo di genitori di alunni frequentanti le scuole materne ed elementari in merito al divieto, agli alunni, di consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta appaltatrice.
Valentino Donà, per lo Sportello Assicurativo, affronta la questione delle“Alluvioni e catastrofi naturali”, traendo spunto dai recenti fatti di Catania. La riflessione parte dal dubbio circa la copertura assicurativa della polizza scolastica in relazione a tali eventi naturali. Alunni e beni sono garantiti? Si rileva come, di fronte a questo stato di cose, le garanzie assicurative legate agli eventi naturali siano ancora poco diffuse e spesso, di fatto, i testi standard di polizza le escludano preventivamente. Sarebbe, quindi, opportuno verificare che non esistano limitazioni o esclusioni almeno in relazione all’infortunio degli alunni e degli operatori scolastici che restino vittime degli eventi catastrofali. Per quanto riguarda gli immobili, l’eventuale estensione della copertura assicurativa per il rischio catastrofale è a carico dell’Ente Locale o del soggetto terzo proprietario della struttura.
Una particolare attenzione, al contrario, andrà posta sui beni di proprietà dell’Istituto scolastico. X










.png)







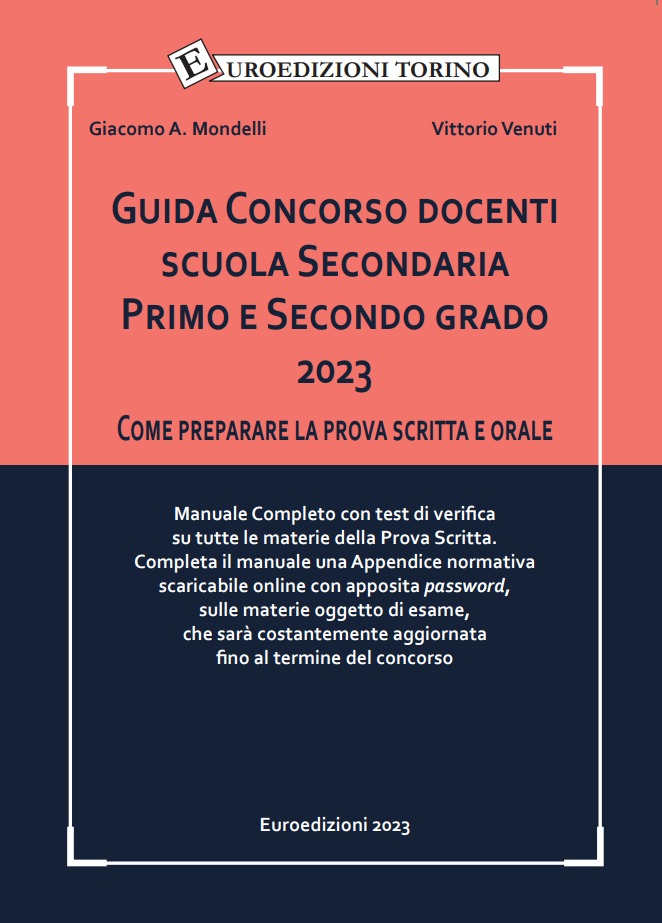
.jpg)






.jpeg)
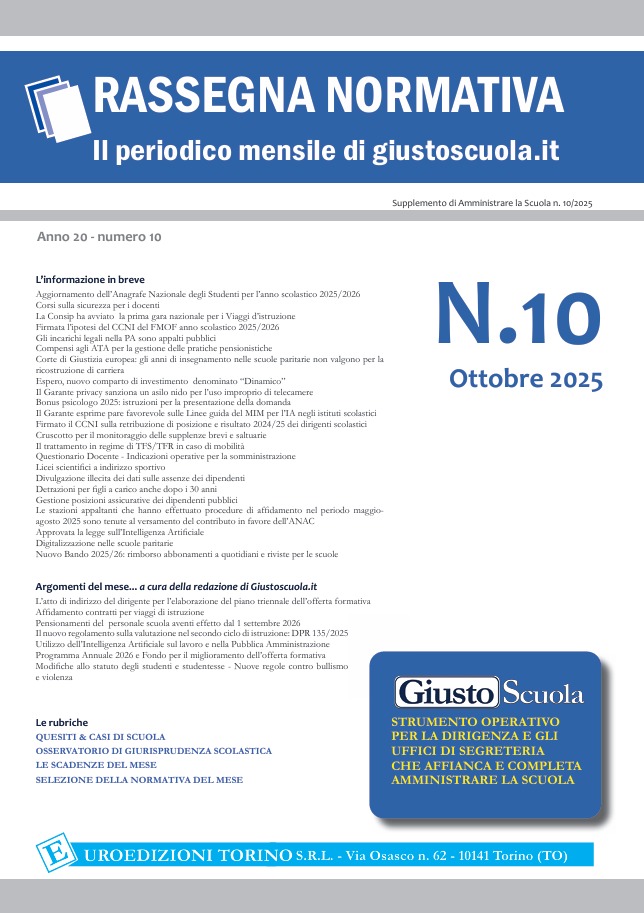
.png)





.jpeg)




