Le prerogative del dirigente nel procedimento valutativo degli apprendimenti
Editoriale di Anna Armone
Direttore Responsabile
Ho tante volte cercato di descrivere la figura dirigenziale. I contenuti e i limiti dei suoi poteri. E ogni volta arrivo alla stessa conclusione: sarebbe stato meglio riflettere a lungo prima di “inventare” questa figura. Una delle occasioni nelle quali emerge la difficoltà di applicare pienamente le prerogative del ruolo dirigenziale è il procedimento valutativo. Si tratta del procedimento più importante messo in campo dall’istituzione scolastica, costituendo percorso e risultato del processo di insegnamento - apprendimento. Per inciso, non bisogna dimenticare come in questo procedimento si realizza una partecipazione necessaria da parte del soggetto destinatario del provvedimento finale, una sorta di compartecipazione necessaria, imprescindibile.
Ma la valutazione degli apprendimenti è un processo a forte contenuto discrezionale tecnico, basato, com’è, su una serie di elementi che vengono filtrati dalla cultura e dalla visione del docente. È vero che il momento collegiale dovrebbe costituire una sorta di trama generale a garanzia dell’equità e della trasparenza, ma le maglie lasciano sempre, in ogni caso, spazio all’individualità valutativa del docente.
Dunque, il primo profilo che vede impegnato il dirigente è quello collegiale. È un’occasione che vede la duplice posizione dirigenziale di presidente dell’organo ma anche organo gestionale che, come afferma il suo profilo, attiva i processi, coordina e indirizza. In qualità di presidente dell’organo svolge le funzioni di “polizia”, come qualsiasi presidente di organo collegiale. In qualità di organo di gestione mette in campo le azioni di “influenzamento” esercitando le sue competenze professionali che derivano dall’aver ricoperto il ruolo di docente.
L’azione valutativa si snoda su due versanti, quello giuridico e quello professionale. Il dirigente interviene sul procedimento amministrativo della valutazione rispettandone i contenuti discrezionali. Vigila sul rispetto delle norme generali (la legge n. 241/1990) e delle norme speciali (il d.p.r. 122/2009 e il d.lgs. 62/2017). Si tratta, dunque, di un controllo di legittimità a garanzia dei soggetti coinvolti nel procedimento, i docenti e gli studenti. La trasparenza, come tutti i canoni della legittimità dell’azione amministrativa, garantisce e tutela gli attori amministrativi, e i docenti, nel procedimento valutativo, da questo punto di vista, sono attori amministrativi. Un procedimento valutativo trasparente è deflattivo, coinvolgendo studenti e famiglie durante l’intero percorso. Ed è proprio in questo attraversamento partecipato che studente e famiglia hanno l’occasione di valutare, dal loro punto di vista, l’equità e la coerenza dell’atto valutativo. Nessuna sorpresa alla fine del percorso, ma condivisione dei vari step. E così assume un valore diverso l’esito finale, positivo o negativo che sia, perché ciò che si condivide lega le parti sull’accettazione del risultato. Dal punto di vista dell’iter giudiziario si comprende facilmente come il reclamo, forma di tutela in via amministrativa, mantiene la sua caratteristica di richiesta correttiva nel caso di errore meramente materiale. È l’attività di difesa giurisdizionale che trova poco spazio applicativo, limitandosi a vizi sopraggiunti all’iter partecipato e condiviso nel corso dell’anno scolastico. Insomma, più trasparenza e partecipazione limitano il contenzioso.
Ma il profilo di legittimità del procedimento valutativo copre una parte del ruolo dirigenziale, vertendo, quello più complesso e rilevante, sull’attivazione del procedimento valutativo. Si tratta di un’azione da non intendersi come limitativa del potere dirigenziale, ma, al contrario, come manifestazione della capacità, unica nel panorama della Pubblica Amministrazione, di influenzare le decisioni di un organo - il collegio dei docenti - posto in una posizione di equiordinazione con il dirigente, e, pertanto, non assoggettabile al potere gerarchico. Il contenuto dell’azione dirigenziale si legge nel suo profilo: attivazione dei processi, indirizzo e coordinamento. Si comprende come tali azioni non afferiscono al diritto amministrativo ma alla scienza dell’amministrazione, poiché risentono delle scienze dell’organizzazione.
Non si tratta di atti ordinatori che obbligano il destinatario a darvi esecuzione, ma di azioni/atti che partono dalla considerazione della variabile più importante, la legittimazione della propria leadership. È comprensibile come un’azione di indirizzo per avere efficacia deve essere accompagnata dal riconoscimento positivo dei destinatari. Un dirigente scolastico è dichiarato leader educativo dalla letteratura e indirettamente anche dal suo profilo, ma è una prova che deve essere avvalorata dal corpo professionale.
Costruire un atto di indirizzo, finalizzato ad attivare un processo valutativo, richiede la consapevolezza del limite del proprio potere, della relatività dell’azione. La capacità di rendere chiare le proprie ragioni, evidenziando nel contempo il rispetto per l’autonomia decisionale del collegio, mette davvero un’ipoteca sull’esito positivo dell’azione.
E di valutazione parla Ivana Summa, ripercorrendo le basi giuridiche, ma soffermandosi sulle questioni di fondo che afferiscono al mondo della didattica e della formazione, al di là degli episodi di cronaca e degli interventi politici su una materia che scava nel profondo della missione della scuola. Cosa si valuta, come si valuta, qual è la funzione della valutazione in itinere, sono queste le domande che non possono trovare risposta nelle norme, ma devono portare alla normazione.
Alessia De Pasquale fa un’approfondita disamina dell’apprendimento linguistico attraverso il teatro. Il saggio affronta gli aspetti tecnici ma fa anche riferimenti esegetici riflettendo sull’origine, sulla radice del teatro, risultando subito evidente come esso abbia da sempre rappresentato un’occasione per apprendere e sia stato utilizzato con tale finalità. L’autrice fa cenno alle ricerche più recenti sull’origine del teatro che sottolineano l’evidente carattere educativo delle sue forme primordiali. Riportiamo il richiamo alla performance primitiva, che, oltre ad avere una valenza rituale-religiosa, trasmetteva delle credenze, narrava delle storie e forniva elementi fondamentali per la formazione personale e sociale.
Massimo Nutini e Gabriele Ventura ricostruiscono l’evoluzione dei finanziamenti per i servizi educativi e scolastici 0-6 anni dal 2017 ad oggi, individuando le criticità del mancato coordinamento tra le diverse linee d’azione e formulando proposte migliorative, per una maggiore efficacia nell’utilizzo delle risorse. Di sicuro interesse per coloro che si occupano di policy school che trovano nello scritto una compiuta analisi organizzativa e giuridica.
Mariagrazia Accorsi fa un’ampia disamina sulle ragioni del disallineamento (frequentemente indicato con il termine ‘mismatch’) tra domanda e offerta di lavoro che ritorna, dopo il periodo pandemico che ha alterato la situazione del mercato del lavoro, ripresentandosi nella sua allarmante larga forbice. L’analisi parte dalle scelte scolastiche e prosegue con l’offerta formativa professionalizzante e le sue carenze e rigidità. Ma ci sono altri punti d’osservazione interessanti, quali le dimissioni dal posto di lavoro, una tendenza assolutamente in controtendenza con la cultura fordista. Ma il clou della trattazione, a parere della scrivente, è il divario di genere nel mondo del lavoro e nella formazione. Come scrive l’autrice, “non possiamo più permetterci lo spreco del capitale umano delle donne, che rappresentano una ricchezza economica, sociale e culturale. L’uguaglianza di genere è da vedersi tuttavia non solo sotto il profilo economico, ma come bene intrinseco, come principio fondante dei diritti umani”.
Carmen Iuvone, già autrice nel n. 3/2023 di un approfondimento sui principi del nuovo Codice dei contratti pubblici, fa una breve rassegna di giurisprudenza amministrativa sul Codice. La rassegna, seppure riferita a casi diversi da quelli scolastici, dimostra la complessità della materia che si sta rivelando di difficile applicazione alle istituzioni scolastiche. Ma proprio per tale complessità è utile la panoramica illustrata dall’autrice. La disciplina generale sugli appalti pubblici, così come emerge dalla giurisprudenza, consente a dirigenti e direttori di comprenderne l’ambito dell’effettiva applicabilità alle istituzioni scolastiche.
Francesco Nuzzaci, partendo da una recente sentenza della Corte di cassazione (peraltro commentata da Federica Marotta nel n. 3/2023) per illustrare e delimitare il mito della libertà di insegnamento. L’autore aderisce alla visione più datoriale della dirigenza scolastica, ampliando i confini del controllo dirigenziale sulle prestazioni dei docenti. Di grande interesse il passaggio della sentenza della Cassazione, con il corredo di inequivoca giurisprudenza, che ha confermato l’integrale vigenza del suddetto articolo 512 del D.Lgs. 297/1994. Tale vigenza è necessaria sino a quando (e se) non venga costruito il dispositivo della performance, a sua volta implicante una valutazione generalizzata, sistematica, ricorrente - potrebbe affermarsi, ordinaria o fisiologica - di tutto il personale della scuola.
Stefano Callà prosegue nella storia della scuola in Italia nel periodo del ’68 richiamando la proposta della de scolarizzazione, che avrebbe voluto essere la soluzione radicale del problema, per affidare alla società, e non più ad un’istituzione separata, costosa e alienante, il compito educativo, ma dimostratasi inadeguata, tanto è vero che è stata sostenuta tanto da sinistra (dall’integralismo di Illich e Reimer al marxismo del “ Manifesto ”) quanto da destra (con l’abolizione del valore legale dei titoli di studio e con la riduzione delle spese “ improduttive ” per la scuola).Contro questa tesi si poneva il Rapporto Faure, che rifiutava parimenti il “numero chiuso”, che avrebbe privato dell’unico canale di ascesa sociale grandi masse di giovani.
Federica Marotta commenta la sentenza del Consiglio di Stato n. 1215/20 avente come oggetto il fenomeno dell’accorpamento degli istituti scolastici, strumento attraverso il quale gli Enti Locali propongono l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di alcuni istituti scolastici presenti su uno stesso segmento di territorio, più o meno ampio, così come previsto all’art.138 del Decreto legislativo n.112 del 1998, attuativo della Legge 59 del 1997. Con detta analisi l’autrice ha voluto cogliere gli aspetti normativi di riferimento per tale materia che è rilevante per il mondo della scuola in quanto l’istituzione scolastica è formata da uomini e donne, da persone che realizzano un servizio importante peri giovani, aventi in comune la necessità di crescere e, soprattutto, di imparare, attività che richiedono all’istituzione scolastica, per la loro natura, una capacità estrema di elasticità, in relazione ai cambiamenti e alle necessità espresse dalla società in cui i fruitori del servizio vivono, crescono e contribuiranno a realizzare, e dalla quale, quindi, sono influenzati. La scuola, per queste ragioni, deve riuscire sempre a trovare un equilibrio, allo scopo di adattarsi alle sempre crescenti e molteplici esigenze espresse dell’utenza, nella cura dell’interesse pubblico di grande importanza che le viene affidato.
Vincenzo Palermo recensisce il primo film, Falcon Lake, di Charlotte Le Bon,evidenziando l’interesse per gli studenti della secondaria superiore a percorsi cinematografici autoriali. Gli elementi messi in luce sono contemporaneamente l’horror e il romanticismo attraverso l’esperienza di un adolescente che sta per entrare nel mondo dei grandi e un ragazzino che sta per entrare nell’adolescenza.
Il secondo film, Lunana, di Pawo Choyning Dorji, spiega in modo semplice e lineare il rapporto osmotico intercorrente tra l’insegnamento e l’apprendimento, aprendosi a riflessioni importanti sul ruolo del docente nella società contemporanea e sull’impatto che ha l’insegnamento nelle zone più povere e meno attrezzate del pianeta.
Il terzo film, Casablanca, è consigliato dal nostro critico perché la riscoperta dei classici cinematografici a scuola è una tappa obbligata per storicizzare la settima arte e far riflettere gli allievi sui differenti modelli di cinema sviluppatisi nel corso del tempo.
Giuliana Costantini recensisce, come prima opera, Oro puro di Fabio Genovesi, la narrazione del viaggio di Cristoforo Colombo alla scoperta delle Americhe attraverso gli occhi di un sedicenne, mozzo di bordo che raccoglie i suoi appunti. Il secondo libro è Corpi dipinti. L’umanità in 21 tatuaggi di Matt Lodder, un racconto sulla storia e sul significato dei tatuaggi. Il libro spazia nella storia del tatuaggio nei diversi Paesi, con il richiamo, altresì, all’uso che ne fanno i giovani e al loro desiderio di non rimanere nel quotidiano grigiore, è l’espressione molto concentrata di emozioni vissute o che si vorrebbero vivere. Il terzo libro Non sparate sulla scuola. Tutto quello che non vi dicono sull’istruzione in Italia di Gianna Fregonara e Orsola Riva parla di scuola, ma dal punto di vista di due madri, giornaliste, che spaziano oltre il significato istituzionale dell’istruzione, ricorrendo a considerazioni di politica scolastica e in particolare relative all’assenza di visione della scuola quale investimento a lungo termine. “Una scuola sostenibile”, curato da Nicola Serio è un testo che ripercorre l’esperienza pedagogico-didattica di un gruppo di pedagogisti appartenenti all’area emiliano-romagnola, luogo che dagli ’70 si è distinta per la capacità innovativa e di ricerca pedagogica. Tra gli autori ricordiamo, tra gli altri, lo stesso Nicola Serio, Rosanna Facchini, Gabriele Boselli e Luciano Lelli, già ispettori dell’USR Emilia Romagna.
Oltre ai testi citati facciamo una menzione speciale ad una giovane artista, Maria Vittoria Biondi, che, attraverso la fotografia e il richiamo ad un giornalismo impegnato, quello dell’Ora, ricostruisce gli eventi drammatici di cronaca palermitana culminati con le morti di Falcone e Borsellino. La prima parte della tesi è dedicata alla ricostruzione della storia del fotogiornalismo e ai suoi grandi protagonisti sparsi per il mondo. Si prosegue con due interessanti interviste a Gaetano Perricone e Franco Lannino. E poi c’è il bianco e nero, drammatico, delle pagine di giornale e dei luoghi evocativi degli eventi narrati. Materiale che narra un percorso di apprendimento attraverso l’arte fotografica, di sicuro interesse per i docenti che curano l’area della creatività. (per chi volesse accedere all’intera opera https://mevy-molly95.wixsite.com/portfolio?fbclid=PAAaaiGJvtk8YEI5SrL59zLVTLKJqQ63NabQSh5kjGoBAGas3yU3sm2rFa4Aaem_ATru-f9AY-mG5dtjRgcNu1h0AuQ203jCMSvgOAxoplX0lPkt-9azyE3QgJHds4un3CA) X






 Una panoramica completa e operativa sul processo di inclusione scolastica
Una panoramica completa e operativa sul processo di inclusione scolastica Un nuovo corso che fornisce a Dirigenti Scolastici, DSGA, docenti accompagnatori e referenti di plesso un quadro completo, operativo e aggiornato sulla corretta gestione dei Viaggi di Istruzione, dalla progettazione alla fase esecutiva. A partire dalle premesse normative e giuridiche sulla vigilanza scolastica, vengono illustrate le responsabilità di scuola e personale, le regole di condotta, gli adempimenti amministrativi e le procedure necessarie per garantire sicurezza, trasparenza e conformità alla normativa vigente.
Un nuovo corso che fornisce a Dirigenti Scolastici, DSGA, docenti accompagnatori e referenti di plesso un quadro completo, operativo e aggiornato sulla corretta gestione dei Viaggi di Istruzione, dalla progettazione alla fase esecutiva. A partire dalle premesse normative e giuridiche sulla vigilanza scolastica, vengono illustrate le responsabilità di scuola e personale, le regole di condotta, gli adempimenti amministrativi e le procedure necessarie per garantire sicurezza, trasparenza e conformità alla normativa vigente.





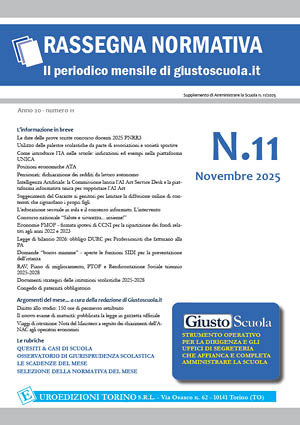
 Come rispettare in modo puntuale gli obblighi di pubblicazione previsti entro il 30 novembre?
Come rispettare in modo puntuale gli obblighi di pubblicazione previsti entro il 30 novembre?

.png) La Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO, organizza un corso di preparazione finalizzato al superamento delle prove scritte concorso dirigenti tecnici con possibilità di correzione degli elaborati
La Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO, organizza un corso di preparazione finalizzato al superamento delle prove scritte concorso dirigenti tecnici con possibilità di correzione degli elaborati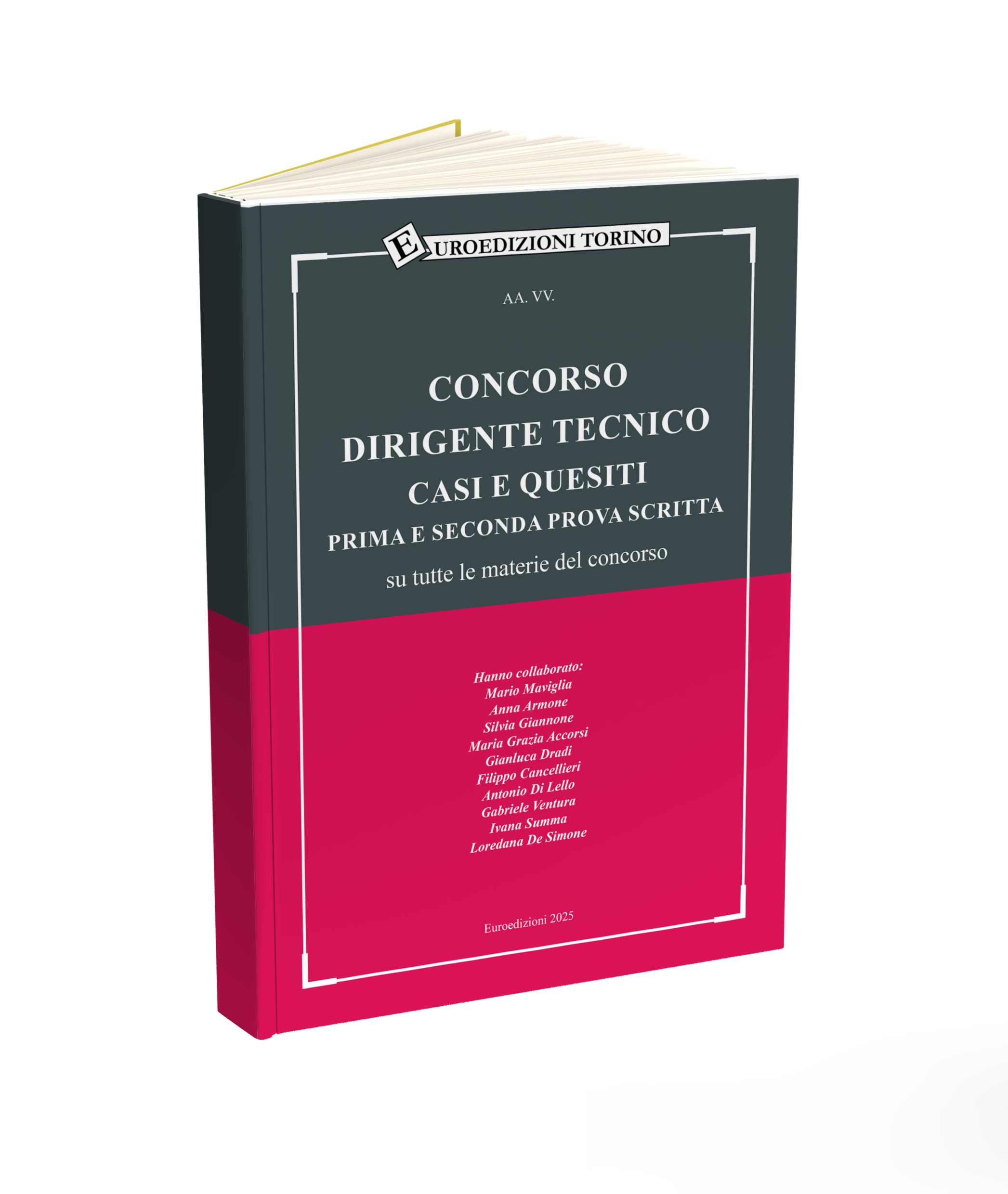 EUROEDIZIONI 2025 - Pagine 592 - Costo 36,00 euro
EUROEDIZIONI 2025 - Pagine 592 - Costo 36,00 euro COME FARE I PROVVEDIMENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE, DOCENTI DI RELIGIONE E DEL PERSONALE ATA
COME FARE I PROVVEDIMENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE, DOCENTI DI RELIGIONE E DEL PERSONALE ATA
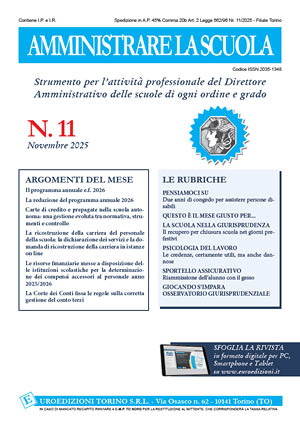
.png) E' stato pubblicato il bando di concorso relativo al reclutamento dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia, i posti messi a bando sono 27.376; si può partecipare in una sola regione. L’istanza è unica, specificando le tipologie di posto o i gradi d’istruzione per cui si possiede il titolo di accesso e si intende concorrere.
E' stato pubblicato il bando di concorso relativo al reclutamento dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia, i posti messi a bando sono 27.376; si può partecipare in una sola regione. L’istanza è unica, specificando le tipologie di posto o i gradi d’istruzione per cui si possiede il titolo di accesso e si intende concorrere. E' stato pubblicato il bando di concorso relativo alla scuola secondaria, i posti messi a bando sono 30.759; si può partecipare in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure su sostegno.
E' stato pubblicato il bando di concorso relativo alla scuola secondaria, i posti messi a bando sono 30.759; si può partecipare in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure su sostegno.

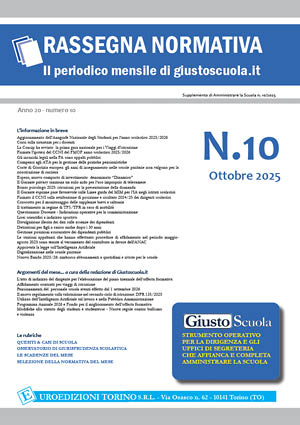
 Relatori: Le lezioni saranno tenute dalla D.ssa Antonietta Di Martino e Ing. Paolo Pieri autori del testo SALUTE e SICUREZZA NELLA SCUOLA Edito da Euroedizioni
Relatori: Le lezioni saranno tenute dalla D.ssa Antonietta Di Martino e Ing. Paolo Pieri autori del testo SALUTE e SICUREZZA NELLA SCUOLA Edito da Euroedizioni
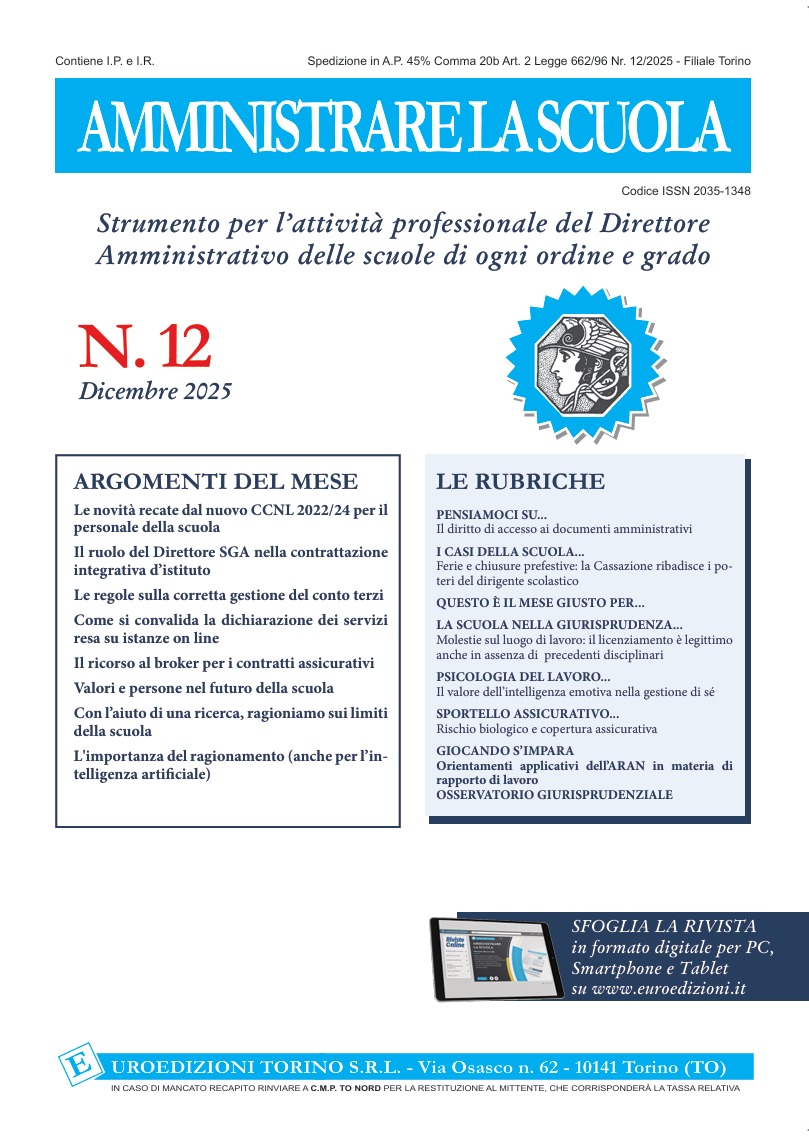


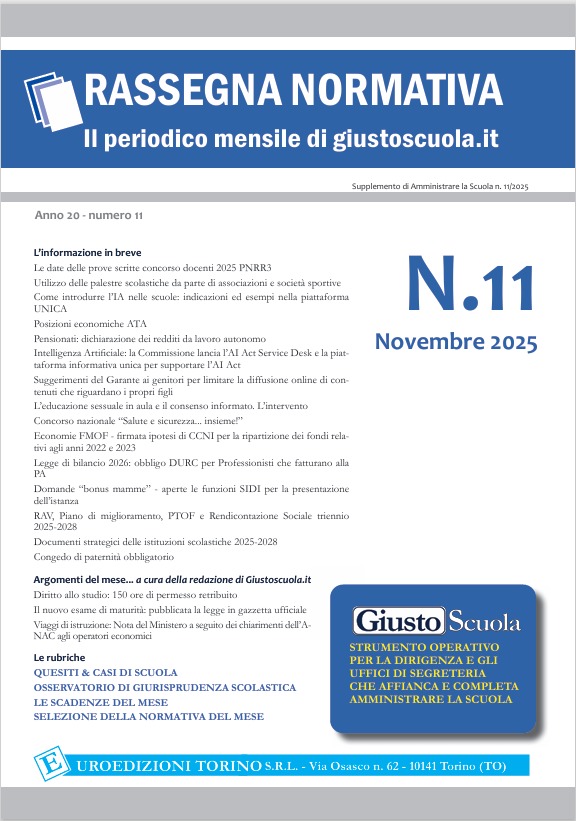
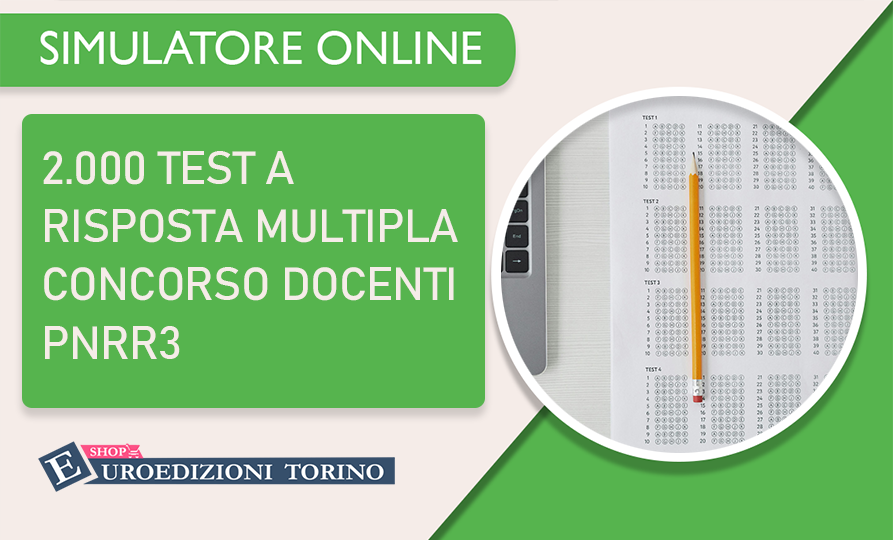
.png)






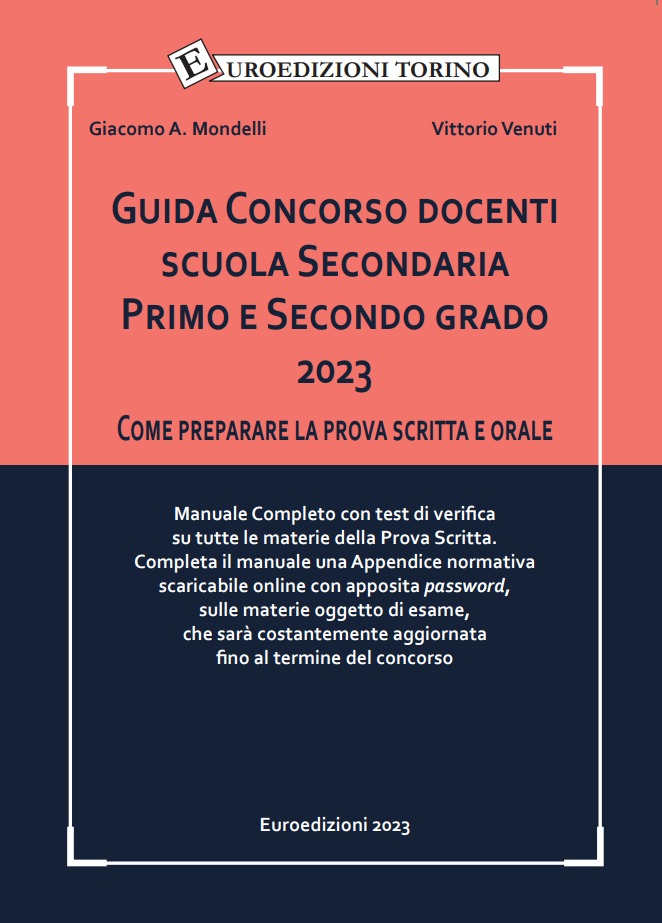
.jpg)





.png)
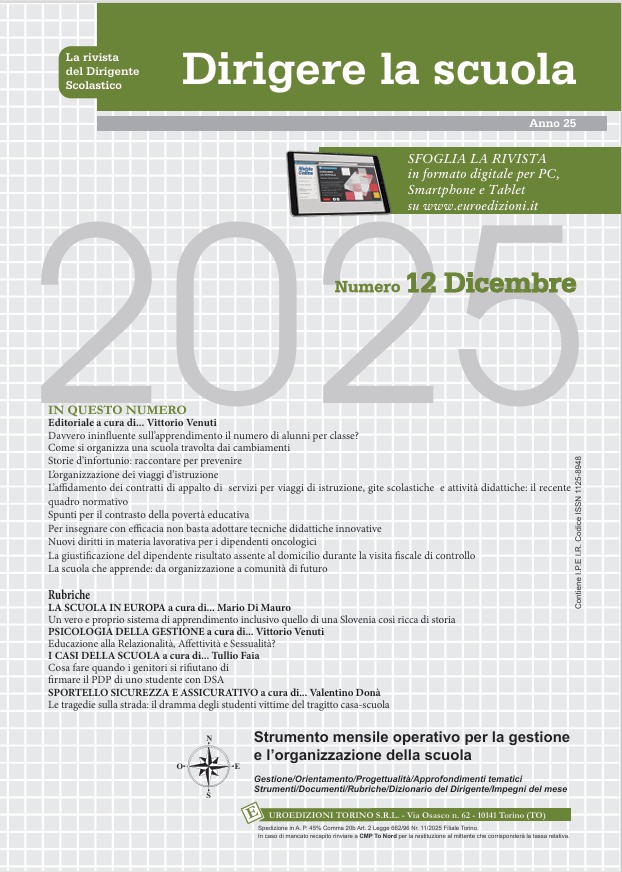
.png)
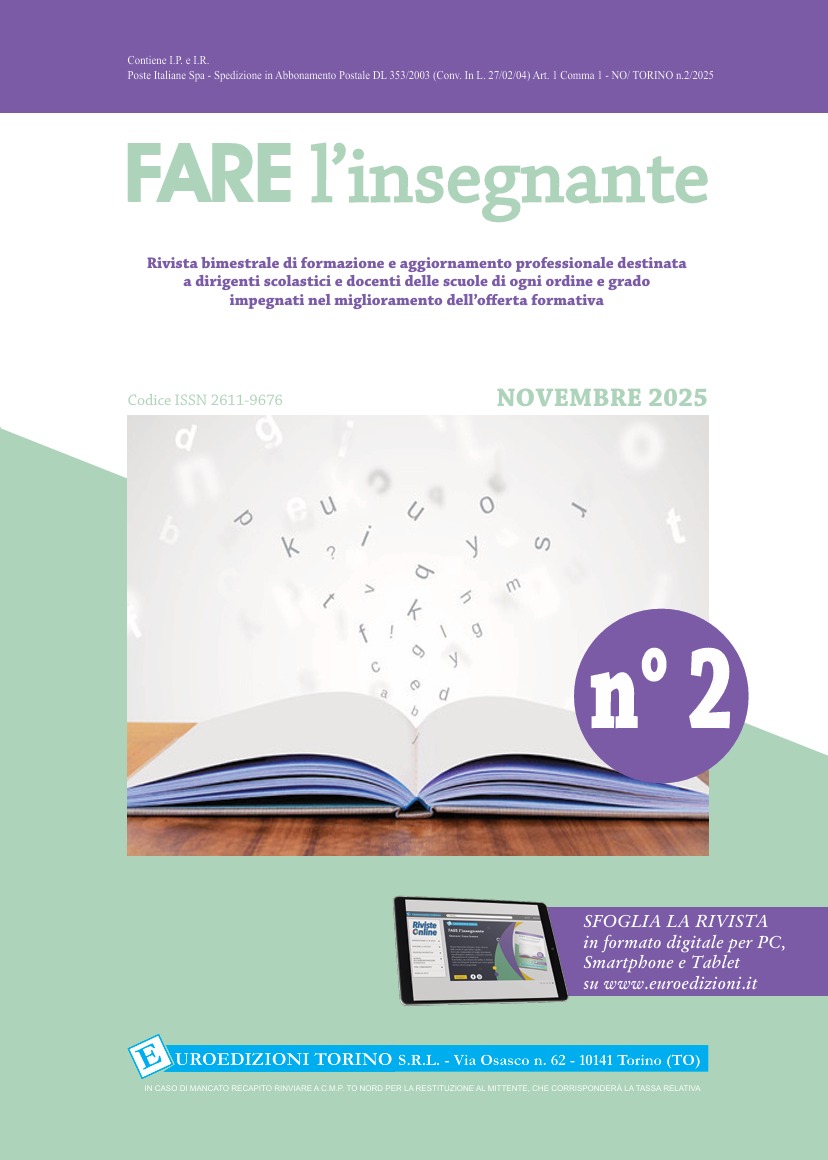

.png)



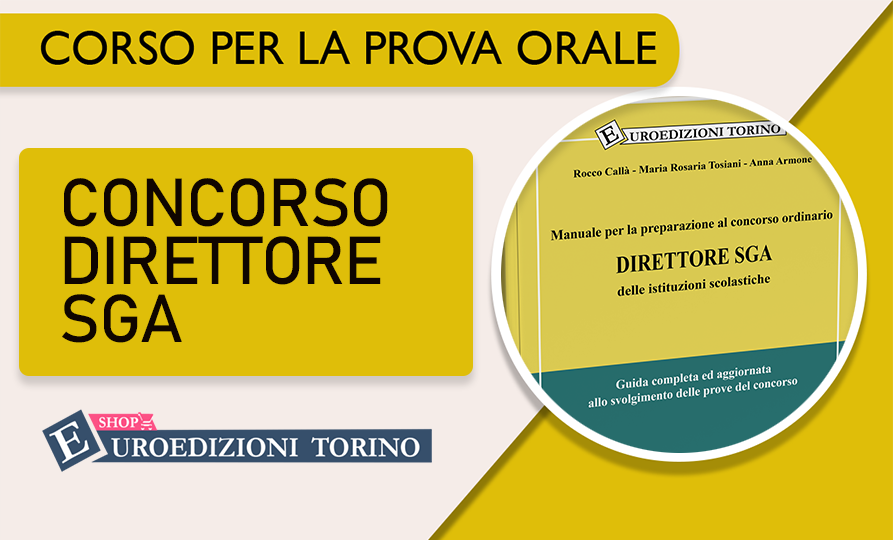
.jpeg)
.jpeg)



